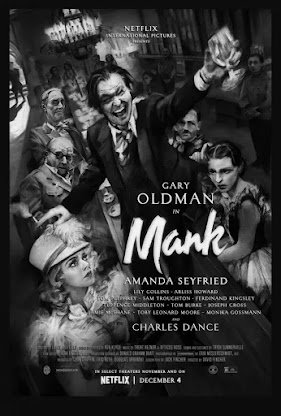di Tim Burton & Henry Selick.
Animazione/Musical
Usa 1993
Il periodo che va dal suo esordio con "Pee Wee's Big Adventure" fino all'uscita de "Il Mistero di Sleepy Hollow" può tranquillamente essere considerato come l'epoca d'oro del cinema di Tim Burton, durante la quale non ha solo ottenuto un fenomenale riscontro di cassetta con ogni suo film, ma è anche entrato nella coscienza collettiva come un artista a tutto tondo, dotato di un proprio stile ed una propria poetica. Nella prima metà degli anni '90 in particolare, Burton è riuscito a concepire alcune tra le sue visioni più celebri ed influenti e, tra tutte, "Nightmare Before Christmas" è la più riconoscibile e originale: uno strano incrocio di influenze che omaggia le festività di Halloween e Natale, allegro ma al contempo smaccatamente cupo, una favola che scioglie il cuore con la sua storia e incanta con le bellissime musiche, che arriva nelle sale appena un anno dopo il perfetto "anti-classico" natalizio, ossia "Batman Il Ritorno", per configurarsi invece come un perfetto film per le feste.
Il soggetto è tratto da una poesia d'infanzia dello stesso Burton (come accaduto con "Edward Mani di Forbice") che gli fu ispirato da un'esperienza particolare, ossia l'aver assistito al cambio di addobbi in un negozio nel periodo di transizione tra la festività di Ognissanti e l'inizio del periodo natalizio "anticipato". La storia vede come protagonista Jack Skellington (che nella versione italiana del film sarà ribattezzato "Skeletron"), superstar del Paese di Halloween che scopre il Natale e cerca di farlo suo, con risultati disastrosi.
Poesia che viene rimaneggiata in uno script dapprima pensato come special televisivo natalizio, poi come lungometraggio vero e proprio. La lavorazione inizia alla fine del 1990 e si protrae fino al 1993. Essendo impegnato con altri progetti, l'autore di Burbank lascia la cabina di regia ad Henry Selick, specialista in animazione passo-uno e qui al suo esordio come regista, ricoprendo il ruolo di mente creativa dietro le quinte. La paternità dell'opera, benché quasi del tutto a lui riconducibile, deve tuttavia essere riconosciuta anche a Selick, il cui lavoro di regia è stato, inutile dirlo, essenziale per lavorazione.
Sbarcato nei cinema di tutto il mondo, "Nightmare Before Christmas" incassa poco più di 90 milioni di dollari, risultato ben lontano da quello mastodontico ottenuto dal dittico su Batman, ma che garantisce lo stesso un ottimo profitto per la Disney, casa produttrice con la quale Burton lavorerà anche per il successivo "Ed Wood"; il tutto a prescindere dallo scetticismo iniziale degli executives, i quali pare abbiano tentato di imporre molte modifiche alla storia e al design, fortunatamente senza successo.
Con il passare del tempo, il film diviene un amatissimo oggetto di culto grazie al suo stile originale, alla storia anticonvenzionale e ai personaggi interessanti e simpatici, imponendosi, un po' alla volta, come un vero e proprio pezzo di cultura pop moderna.
E "anticonvenzionale" è proprio l'aggettivo che meglio qualifica il lavoro di Burton e Selick, a partire dalla storia e dal suo protagonista. Jack non è un reietto nel senso proprio del termine, trovata singolare nel cinema di Burton; è una star, il capo di Halloween Town e primadonna nelle celebrazioni, ma, come spesso accade ad un altro archetipo, quello delle principesse Disney, Jack si accorge di come il mondo in cui vive è in realtà una gabbia dorata, un universo che gli va stretto e dal quale vorrebbe fuggire, non tanto per trovare una forma di emancipazione o realizzazione, ma per provare sentimenti nuovi. Occasione che si presenta con la visita a Christmas Town e la scoperta del Natale, una ricorrenza dove al posto degli spaventi c'è la gioia; il che porta ad un'altra nota di originalità nella filmografia di Tim Burton: laddove il diverso non vuole per davvero omologarsi, quanto meno vuole recuperare quei valori dai quali normalmente si dissocerebbe. La massificazione commerciale propria del periodo natalizio (se ne parlava anni fa nel post su "Silent Night, Deadly Night") per Burton ha una valenza infantile, ancora magicamente ancorata al calore e all'amore.
La "morale" di questa favola dark non risiede in un conformistico castigo verso il protagonista il quale si avventura scioccamente in un mondo non suo, come pur si potrebbe pensare. Burton opera più di fino e fa di Jack una metafora, di molto in anticipo sui tempi, sull'appropriazione culturale, o almeno così può essere letta. Jack sbaglia nel non riuscire a comprendere il significato del Natale e a replicarne i riti in modo personale e superficiale, lontano da quello che questi rappresentano, da cui la baraonda con i regali assassini che divorano lo spirito delle festività. Nel finale, Santa Claus regala anche agli abitanti di Halloween Town un vero Natale, prova di come anche loro, benché "diversi", possono goderne, purché ne comprendano e rispettino lo spirito. Jack è così l'antagonista di sé stesso (Oogie Boogie è un villain puramente circostanziale, il cui operato non causa veri danni nella storia) o, per meglio dire, il suo entusiasmo privo di riflessione è la vera forza disgregatrice, la quale non viene tanto castigata, quanto ricondotta a ragione. Prova di come Burton provi un sentimento di vera affezione verso questo strano "non-freak" della sua filmografia.
Il lavoro sulla messa in scena è, per usare un eufemismo, mastodontico: quasi 3 anni e mezzo di lavorazione, un team di 120 persone tra animatori e scenografi, set giganteschi e rifiniti nei minimi dettagli per quello che resterà fino a "La Sposa Cadavere" come il più grande film in stop-motion mai realizzato.
Grandezza eguagliata solo dallo stile. Come in "Batman Il Ritorno", l'influenza dell'espressionismo tedesco è tangibile e supera quella del gotico classico. Le forme sghembe delle scenografie, il look filiforme di Jack e il design di tutto il cast di personaggi rimanda in modo diretto a "Il Gabinetto del Dr.Caligari", mentre il personaggio di Sally, la "bambola di pezza sgualcita", è un'evoluzione della Catwoman burtoniana votata al bene puro, le cui forme ricordano le illustrazioni vittoriane.
Come in ogni musical che si rispetti, la cura della colonna sonora è essenziale e Burton torna a collaborare con il fido Danny Elfman per creare delle canzoni suggestive e orecchiabili. La canzone di Halloween Town e l'ossessiva "What's this" finiscono per essere i pezzi migliori oltre ai più indimenticabili, ma non sono da meno il tema di Oogie Boogie o la canzone con cui Jack realizza i propri errori. Da elogiare è anche la versione italiana, con il contributo di Renato Zero nei panni di Jack che supera persino l'originale, rendendo i numeri musicali ancora più perfetti.
La struttura da musical viene pienamente rispettata, ma più che portare avanti la storia, le canzoni offrono uno scorcio nelle emozioni dei personaggi, divenendo vere e proprie poesie esistenzialiste messe in musica e garantendo un tono quasi opprimente nel loro indugiare sul malessere del protagonista.
Il mix di livore e allegria finisce così per essere perfetto e riesce a coinvolgere sin nel profondo, rendendo il film come un'opera non solo perfettamente riuscita, ma al contempo potente e memorabile, come solo il grande cinema sa essere. Oltre che a renderla perfetta per le celebrazioni natalizie.