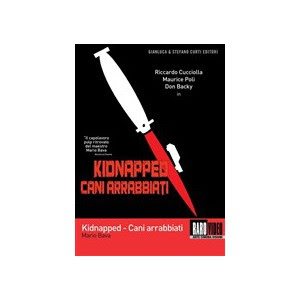di Eli Roth
con: Lorenza Izzo, Ariel Levy, Aaron Burns, Mgda Apanowicz, Kirby Bliss Blanton, Ignacia Allamand.
Usa, Cile- 2013
Eli Roth è uno che ci crede davvero. E' davvero, fortemente, convinto che sia possibile riproporre i fasti del cinema splatter italiano anche in un contesto moderno e a prescindere dal clima politico, sociale e produttivo che portò alla nascita e fioritura del filone. E di fatto, fin dai suoi esordi ha tentato di rifarsi sempre e comunque a stili, stilemi e correnti esistenti, anche oltre quelli nostrani, rileggendoli in chiave furba, cinefila e compiaciuta, non tanto per creare qualcosa di nuovo o sperimentare nuove forme estetico-narative, quanto per sfoggiare la sua voglia di omaggiare i classici. Omaggio che però non si sostanzia nella ripresa cosciente di singoli elementi, quanto nella riproposizione coatta di clichè, intrisi di tanta, troppa voglia di stupire e spiazzare. Con risultati risibili.
Non è un mistero il fatto che il suo esordio "Cabin Fever" (2002) fosse nato come semplice variazione sul tema slasher, nel quale al fattore shock o alla semplice onestà di intrattenitore si sostituiva una carica autoriale beffarda che distruggeva ogni forma di immersione per lo spettatore; al punto che il produttore David Lynch, schifato dal risultato, decise di disconoscerlo.
Ma il successo di quel filmino da quattro soldi aprì a Roth le porte dell'Olimpo, che per lui aveva il nome di Quentin Tarantino, ossia il Re Mida dei registi cinefili. Peccato che Roth non avesse un'oncia del talento distruttivo e sperimentale del suo mentore e la loro prima collaborazione, il famigerato "Hostel" (2004), si sia rivelata come la pellicola più ruffiana e compiaciuta che il revival splatter abbia conosciuto.
Nove anni dopo, dopo un sequel della sua creatura più fortunata e varie comparsate per l'amico Quentin, Roth, imperterrito, torna alla carica prendendo di mira questa volta il filone cannibale, unendo i primi due capitoli della trilogia di Ruggero Deodato, "Ultimo Mondo Cannibale" (1977) e "Cannibal Holocaust" (1980), purgandoli da qualsiasi risvolto polemico, riducendo la violenza a mero shock viscerale per creare un film ipocrita e sottilmente razzista. Che dopo un limbo distributivo durato due anni, arriva in Italia in anteprima mondiale, in una mossa di merketing dal sapore cinefilo posticcio.
A differenza di "Hostel", qui Roth dimostra una maggiore serietà nel portare in scena la violenza. "Serietà" non intesa nel senso stilistico, che anzi manca, quanto come onestà verso lo spettatore: al bando ogni forma di rimando o ritardo, il gore fa capolino puntuale da metà film in poi, nella forma dei disgustosi e magnifici effetti di Nicotero e Berger, che trasformano i pallidi personaggi in portate di un banchetto davvero sadico, dove la violenza urlata in faccia riesce finalmente ad essere disturbante, per quanto compiaciuta.
Ma al di là di questa ritrovata, quanto parziale, forma di rispetto verso il pubblico pagante, non ci sono altri meriti effettivi in questo "The Green Inferno", primo fra tutti il rispetto verso le pellicole a cui si ispira.
La trilogia di Deodato ben si presta, tutt'oggi, alle critiche sulla gratuità della violenza, sia vera che finta, ma riusciva indubbiamente a generare nella mente di chi la guardava una riflessione potente sul concetto stesso di violenza, oltre che sul razzismo insito nell'uomo bianco.
A Roth tutto questo, ovviamente, non interessa. Per lui i personaggi sono solo degli idioti, non dei carnefici, buoni solo per essere derisi e sbudellati. Per tutta la prima metà, si diverte a perculare la moda ecologista degli universitari e l'ossessione per la ripresa digitale e lo streaming degli eventi come forma di coscienza virale. La protagonista Justine (Lorenza Izzo) altro non è che la perfetta "maschera bianca" che subisce il lavaggio del cervello del carismatico Alejandro (Ariel Levy) per partecipare alla protesta in Perù. L'impegno sociale e politico giovanile viene deriso e descritto come pura moda, gli attivisti come radical chic afflitti dai sensi di colpa borghesi. Il riferimento più ovvio è ai gruppi Anonymus e per gli Italiani non sarebbe sbagliato rivedere il modus operandi del Moviemnto 5 Stelle di Grillo. Ma quanto c'è di sensato in questa critica?
Poco o nulla. Roth fa sicuramente bene a demolire il mito dell'impegno coatto, ma nel momento in cui generalizza la sua posizione, caratterizzando tutti i personaggi come un gruppo di imbecilli ed il loro capo come un idiota, deviato e corrotto, cade nella sua stessa trappola, disvelando un punto di vista troppo parziale e sbruffonesco. Il suo status di "benestante ebreo bianco", che in teoria lo dovrebbe rendere uguale ai suoi personaggi, tradisce invece una supercialità fastidiosa: vien da chiedersi se Roth abbia mai davvero partecipato ad una riunione di un qualsiasi gruppo di attivisti, se ne abbia conosciuto davvero o qualcuno o anche solo letto i loro proclami. Molto più probabilmente, si è limitato solo a guardare qualche viedo (magari in streaming) e deciso di etichettare tutto come "idiozia".
Perchè i due personaggi principali, Justine ed Alejandro, sono davvero troppo caricaturali per essere credibili o assurgere a "spauracchio". La prima è una ragazza, si, benestante, ma scopre una forma vivida di interesse verso il "male" del mondo. Ma allora perchè una volta rincasata decide di prendere le difese dei suoi aguzzini in modo beffardo ed ostinato? Perchè a Roth non interessa la coerenza narrativa, ma solo l'insulto spregiudicato verso una categoria di persona che pretende di conoscere e saper analizzare. Allo stesso modo Alejandro dovrebbe essere una sferzata contro i carismastici radical chic che inscenano forme di protesta per scrollarsi di dosso i sensi di colpa. Ma nel momento in cui si rivela non solo colluso con le aziende che combatte, ma anche sadico e beffardo sino alla devianza, il discorso finto-moralista perde di ogni credibilità. Così come la credibilità di tutta l'operazione.
La critica alla tanto demonizzata moda della videoipresa con smartphone, che qui vorrebbe sostituire il vouyersimo di "Cannibal Holocaust" senza riuscirci, fa poi scadere il tutto nel ridicolo involontario quando ci si accorge non solo che l'intero film è girato in digitale, ma che sui titoli di coda spuntano gli account Twitter di regista e cast, in un controsenso spiazzante.
Cosa vuole davvero dire Roth? Che l'ossessione della ripresa digitale è stupida o innocua? Che la moda della condivisione di ogni singolo evento di vita è vergognosa o "figa"? Quesiti dall'ardua risposta, visto il cortocircuito cerebrale che ammanta l'autore e la sua visione.
Visione che, in generale, vorrebbe rifarsi al cinema anni '70 senza mai riuscirci davvero. Roth non è Tarantino, ma neanche Rob Zombie: non ha il gusto per la citazione o il polso fermo nella messa in scena. La fotografia blanda e l'uso di inquadrature brutte e sghembe più che richiamare alla mente il cinema di Deodato fa ripensare agli obbrobri di Umberto Lenzi ed il suo "Cannibal Ferox" (1981) o l'apripista di tutto il filone "Il Paese del Sesso Selvaggio" (1972); e non è un merito: la sgrammaticatura non diviene cifra estetica, ma solo dolore per chi guarda.
E gli intenti di Roth si sfaldano totalmente nella "costruzione" dei personaggi: tutti si rifanno agli stereotipi dello slasher americano. Al bando i cinematografari sadici di Deodato, Justine e soci sono del tutto assimilabili ad ogni singolo luogo comune visto in decenni di squartamenti a stelle e strisce; la protagonista è la classica "final girl", dalla bellezza un pò ingenua che cela la canonica incredibile forza d'animo; il fattone del gruppo fa la fine peggiore; il nero, questa volta anche sovrappeso per fondere insieme due stereotipi, è il primo a tirare le cuoia; la ragazza più carina ha un crollo psicologico, quella forte viene massacrata e, in omaggio ai tempi che cambiano, le due sono lesbiche, o, per meglio dire, sono impegnate in una relazione lesbica, visto che esteticamente ricordano la classica reginetta e la punk rocker.
Lo scivolone maggiore però lo si ha quando entrano in scena i cannibali, ridotti a puri mostri. Non più i "buoni selvaggi" inselvatichiti dal contatto con la cattiveria dell'uomo civile, gli Indios sono qui delle creature inutilmente feroci e sadiche. Il discorso di Roth vorrebbe rifarsi a quello di "Cannibal Holocaust", inscenando nel velocissimo prologo una giustificazione dovuta al disboscamento, ma nel momento in cui non fa discernere ai sui cannibali la differenza tra buoni e cattivi, scivola automaticamente nel razzismo più becero. Perchè, davvero, è impossibile non vedere una contrapposizione tra il civilizzato nordamerica e il selvaggio sud, infestato da uomini d'affari che si circondano di guerriglieri dal grilletto facile e cacciatori di teste. Discorso che Roth già intavolava con "Hostel": in sostanza, la civiltà appartiene solo agli yankee, al di là dei confini ci sono solo assassini psicopatici. Il che rende il suo status di "ebreo bianco benestante" ancora più velleitario ed ipocrita.
La violenza, si diceva, questa volta fa capolino puntuale. Ma l'uso di un registro grottesco non giova; oltre a non essere Tarantino, né Rob Zombie, Roth non è neanche Adam Wingard e non sa coniugare umorismo nero e splatter senza distruggere la sospensione dell'incredulità. Davvero ridocola la trovata di far "sballare" gli Indios con un pacchetto di marjuana nascosto in un cadavere o, peggio, quella di far defecare rumorosamente la bella del gruppo in preda al panico. La violenza tinta di umorismo idiota funziona meglio quando resta confinata a singoli inserti, come nella scena del post-atterraggio, ma in generale fa scadere il tutto ad una pantomima come al solito compiaciutissima.
Tanto che alla fine si comprende appieno come Roth non abbia nessuna capacità autoriale. Non riesce a rendere un omaggio sincero ai film che ama, non è in grado di rinverdirne i fasti, nè a creare una riflessione riuscita sulle ossessioni moderne. Forse perchè, alla fin fine, anche lui non è che uno stupido borghese afflitto dai sensi di colpa. Non quelli derivanti dallo sfruttamento dei più deboli, ma quelli, più castranti, di essere un miracolato, un uomo che continua a trovare l'attenzione del pubblico solo perchè amico di Tarantino. Un amico privo di qualsiasi talento.
lunedì 28 settembre 2015
domenica 27 settembre 2015
Le Notti di Salem
Salem's Lot
di Tobe Hooper.
con: David Soul, James Mason, Bonnie Bedelia, Lance Kerwin, Elisha Cook Jr., Kenneth McMillian.
Horror
Usa. 1979
L'astio di Stephen King verso il mezzo cinematografico è cosa risaputa ed esilarante. E' noto a tutti, sopratutto ai lettori della prima ora, come King odi le riduzioni dei suoi scritti ai quali non abbia partecipato come sceneggiatore, "colpevoli" di travisare, tagliare o stravolgere il romanzo di partenza per creare qualcosa di nuovo. Ma da buon professore di letteratura e scrittore affermato, King non ha capito (o forse non vuole ammettere) le necessarie differenze esistenti tra il mezzo filmico e quello cartaceo: molte storie, descrizioni, risvolti o situazioni descritte nei suoi libri, trasposti su schermo risulterebbero fiacche o, peggio, ridicole. Tuttavia, come ogni autore affermato, anche King è un integralista integerrimo, quindi più che ammettere le difficoltà di trasposizione, preferisce gettare vetriolo sui registi e sceneggiatori che hanno portato le sue storie al cinema. Creando un effetto a dir poco ilare: impossibile prendere sul serio le critiche mosse allo "Shining" (1980) di Kubrick o all'odiatissimo "La Zona Morta" (1982) di Cronenberg, veri e propri capolavori di stile e contenuto che riescono a reinterpretare la materia di base rendendola ancora più fulgida ed espressiva.
Discorso dissacratorio che si fa puramente ipocrita se si tiene conto di come King, di fatto, debba la sua fama proprio ad una trasposizione di un suo scritto piuttosto che al libro in sé: "Carrie" di Brian De Palma, che nel 1976 sbancò i botteghini di tutto il mondo ed impose il nome di King come decano dell'horror.
D'altro canto le difficoltà nel trasporre i romanzi dell'autore del Maine sono palesi a chiunque ci si sia avvicinato: tonnellate e tonnellate di personaggi descritti fin nei minimi dettagli, costruzione della storia anticlimatica, estrema frammentazione del punto di visto e della composizione narrativa. In sostanza: tutto quello che con King funziona alla grande su carta, diviene o può divenire automaticamente un grosso difetto nella narrazione cinematografica. La semplificazione dei personaggi, sopratutto sul piano quantitativo, è quindi d'obbligo, così come la ricostruzione della storia su di un binario più lineare.
E tra adattamenti fedeli sin nelle virgole ed altri decisamente più liberi, a metà strada si pone il celebre "Le Notti di Salem", trasposizione del secondo romanzo di genere, nonchè primo vero successo commerciale, di King, diretta nel 1979 da Tobe Hooper.
Ambientato nella remota cittadina di Salem's Lot, nell'amato Maine, "Le Notti di Salem" è un romanzo horror atipico ed affascinante: una tranquilla cittadina, nella quale anni prima si era consumato un terribile delitto nella magione di Marston, viene sconvolta nuovamente da una serie di morti e sparizioni dopo che tre stranieri vi si stabiliscono. Questi sono lo scrittore Ben Mears, l'affascinante uomo d'affari Straker e il suo misterioso socio, lo sfuggente Kurt Barlow.
Ispirandosi a "I Peccati di Peyton Place" e al caposaldo del genere "Dracula" di Stoker, King fonde l'horror con lo spaccato di vita; gran parte della narrazione è incentrata sulla descrizione delle vite dei personaggi che popolano il borgo: vite semplici, apparentemente tranquille, ma che sotto sotto nascondono segreti violenti o ipocrisie distruttive. Tutti i personaggi sono spogliati di ogni forma di idealizzazione e mostrati come creature infelici e ossessive. L'orrore subentra così in una quotidianità distrutta dalla propria pochezza per annientare quel poco di buono che ciascuno ha. Orrore che ha un duplice volto. da un lato la magione, teatro di stragi e soprusi che sembra aver assimilato il male che vi si è consumato (tema che King riprenderà nel successivo "Shining"), dall'altro il vampiro che vi si trasferisce, portando in paese una piaga che muterà per sempre i suoi abitanti.
Confrontandosi la figura mitica del vampiro, King dimostra un amore smisurato per la tradizione che lo ha forgiato, sia filmica che letteraria. Il non-morto è qui un uomo affascinante ed affabile, che crea i suoi sottoposti promettendo loro una vita migliore. Le sue fattezze sono quelle di una persona di bell'aspetto, nel quale la componente sessuale risulta più marcata. Ma al contempo, il terrore che incute è primordiale e tangibile, in un misto di attrazione e repulsione che ripropone la dicotomia tra eros e thanatos che lo ha reso celebre.
Il successo del libro fu immediato e sorprendente, tanto che appena quattro anni dopo la pubblicazione parte il progetto di adattamento; questa volta non per il cinema, bensì per la televisione, medium che negli anni '90 ospiterà più volte le opere di King con risultati spesso mediocri, ma che a causa della possibilità di scindere il racconto il più parti ben si adatta alla trasposizione di romanzi. La produzione di "Salem" viene graziata dalla scelta di un regista capace, quell'Hooper che qualche anno prima aveva sconvolto tutti con il viscerale "The Texas Chainsaw Massacre" (1974) e che qui dimostra un polso fermo anche per l'horror più "classico".
Trasporre su schermo le oltre 600 pagine del romanzo e la mole elefantiaca di personaggi non era certo impresa semplice. Ma Paul Monash, già esperto in quanto sceneggiatore della serie televisiva proprio di quel "Peyton Place" che fu d'ispirazione, riesce nell'impresa in modo esemplare: riduce il numero dei personaggi fondendo tra loro ruoli e caratteri in modo da gestirli meglio. I personaggi principali sono tutti lì: lo scrittore Ben Mears dilaniato dai sensi di colpa ed affascinato dal male incombente, che ora ha il volto di David Soul, l'Hutch di "Starsky e Hutch" e che qui si rivela scelta felice, il giovane e vendicativo Mark Petrie, l'inesperta e naif Susan Norton; e sopratutto Straker, la cui caratterizzazione viene resa ancora più sottile e il cui ruolo viene affidato all'immenso James Mason, che riplasma il personaggio in un misto di cattiveria viscerale e sottomissione al suo "padrone", quel Barlow che qui viene spogliato da qualsiasi influenza del Dracula filmico per rifarsi a "Nosferatu il Vampiro" (1922) di Murnau, divenendo una figura mostruosa ed incredibilmente spaventosa. Uniche perdite sono i personaggi di Padre Callahan e Matt Burke: il primo fa una semplice comparsata ed il suo calvario fatto di fede non proprio ferrea e dipendenza dalla bottiglia è assente, mentre il seondo, ribattezzato "Jason", non ha il ruolo di novello Van Helsing che aveva nel libro.
La natura televisiva ha purtroppo fatto invecchiare male l'opera di Hooper. Gli scarsi valori produttivi si riverberano non tanto sugli effetti, che invece sfoggiano una cura inusuale ed ancora efficace, quanto nella messa in scena, molto semplice, talvolta fatta una sola inquadratura per scena ed afflitta da una fotografia scarna.
Di tutt'altro livello sono le sequenze squisitamente d'orrore, nel quale Hooper dà provadi grande maestria. La scena del ritorno del piccolo Danny Glick dal fratello, sotto forma di succhiasangue, stupisce per carica visionaria. Ma è l'entrata in scena di Barlow a costituire il pezzo forte del film: un primo piano voltato a jump-scare che gela il sangue nelle vene, semplicemente da manuale. Così come da antologia è la sequenza della sua distruzione: tesa quasi fino alla disperazione ed incredibilmente espressiva. Monash ed Hooper riescono poi semplificare la conclusione del romanzo senza perdere un'unghia della sua carica di tensione ed aggiungo un epilogo cattivo ed ancora più spiazzante di quello del libro.
In generale, a stupire è la capacità dei due autori di trasporre il senso di terrore sottile e strisciante che permea il romanzo, nonchè il senso di cupezza e tensione utilizzando le basi della messa in scena.
Il successo della mini-serie (due episodi da 90 minuti ciascuno) all'epoca fu notevole, tanto che ne venne creata anche una versione cinematografica da 104 minuti. Per forza di cose, molti degli elementi descrittivi e delle sottotrame sono state eliminate, ma anche questa versione risulta interessante e inquietante, anche grazie agli effetti splatter aggiunti alle scene più cruente.
Naturalmente, la visione della versione integrale resta preferibile, sopratutto per comprendere l'ottima opera di adattamento di Monash, che per una volta pare che non scontentò neanche King.
EXTRA
Nel 2004, l'emittente via cavo TNT ha prodotto un nuovo adattamento di "Salem's Lot". Nonostante un cast di prim'ordine, composta da Rob Lowe, Donald Sutherland, James Cromwell e Rutger Hauer, questa nuova versione non è ai livelli dell'originale di Hooper, a causa della sceneggiatura, questa volta troppo rispettosa del testo originario e della regia piatta e poco ispirata.
Discorso dissacratorio che si fa puramente ipocrita se si tiene conto di come King, di fatto, debba la sua fama proprio ad una trasposizione di un suo scritto piuttosto che al libro in sé: "Carrie" di Brian De Palma, che nel 1976 sbancò i botteghini di tutto il mondo ed impose il nome di King come decano dell'horror.
D'altro canto le difficoltà nel trasporre i romanzi dell'autore del Maine sono palesi a chiunque ci si sia avvicinato: tonnellate e tonnellate di personaggi descritti fin nei minimi dettagli, costruzione della storia anticlimatica, estrema frammentazione del punto di visto e della composizione narrativa. In sostanza: tutto quello che con King funziona alla grande su carta, diviene o può divenire automaticamente un grosso difetto nella narrazione cinematografica. La semplificazione dei personaggi, sopratutto sul piano quantitativo, è quindi d'obbligo, così come la ricostruzione della storia su di un binario più lineare.
E tra adattamenti fedeli sin nelle virgole ed altri decisamente più liberi, a metà strada si pone il celebre "Le Notti di Salem", trasposizione del secondo romanzo di genere, nonchè primo vero successo commerciale, di King, diretta nel 1979 da Tobe Hooper.
Ambientato nella remota cittadina di Salem's Lot, nell'amato Maine, "Le Notti di Salem" è un romanzo horror atipico ed affascinante: una tranquilla cittadina, nella quale anni prima si era consumato un terribile delitto nella magione di Marston, viene sconvolta nuovamente da una serie di morti e sparizioni dopo che tre stranieri vi si stabiliscono. Questi sono lo scrittore Ben Mears, l'affascinante uomo d'affari Straker e il suo misterioso socio, lo sfuggente Kurt Barlow.
Ispirandosi a "I Peccati di Peyton Place" e al caposaldo del genere "Dracula" di Stoker, King fonde l'horror con lo spaccato di vita; gran parte della narrazione è incentrata sulla descrizione delle vite dei personaggi che popolano il borgo: vite semplici, apparentemente tranquille, ma che sotto sotto nascondono segreti violenti o ipocrisie distruttive. Tutti i personaggi sono spogliati di ogni forma di idealizzazione e mostrati come creature infelici e ossessive. L'orrore subentra così in una quotidianità distrutta dalla propria pochezza per annientare quel poco di buono che ciascuno ha. Orrore che ha un duplice volto. da un lato la magione, teatro di stragi e soprusi che sembra aver assimilato il male che vi si è consumato (tema che King riprenderà nel successivo "Shining"), dall'altro il vampiro che vi si trasferisce, portando in paese una piaga che muterà per sempre i suoi abitanti.
Confrontandosi la figura mitica del vampiro, King dimostra un amore smisurato per la tradizione che lo ha forgiato, sia filmica che letteraria. Il non-morto è qui un uomo affascinante ed affabile, che crea i suoi sottoposti promettendo loro una vita migliore. Le sue fattezze sono quelle di una persona di bell'aspetto, nel quale la componente sessuale risulta più marcata. Ma al contempo, il terrore che incute è primordiale e tangibile, in un misto di attrazione e repulsione che ripropone la dicotomia tra eros e thanatos che lo ha reso celebre.
Il successo del libro fu immediato e sorprendente, tanto che appena quattro anni dopo la pubblicazione parte il progetto di adattamento; questa volta non per il cinema, bensì per la televisione, medium che negli anni '90 ospiterà più volte le opere di King con risultati spesso mediocri, ma che a causa della possibilità di scindere il racconto il più parti ben si adatta alla trasposizione di romanzi. La produzione di "Salem" viene graziata dalla scelta di un regista capace, quell'Hooper che qualche anno prima aveva sconvolto tutti con il viscerale "The Texas Chainsaw Massacre" (1974) e che qui dimostra un polso fermo anche per l'horror più "classico".
Trasporre su schermo le oltre 600 pagine del romanzo e la mole elefantiaca di personaggi non era certo impresa semplice. Ma Paul Monash, già esperto in quanto sceneggiatore della serie televisiva proprio di quel "Peyton Place" che fu d'ispirazione, riesce nell'impresa in modo esemplare: riduce il numero dei personaggi fondendo tra loro ruoli e caratteri in modo da gestirli meglio. I personaggi principali sono tutti lì: lo scrittore Ben Mears dilaniato dai sensi di colpa ed affascinato dal male incombente, che ora ha il volto di David Soul, l'Hutch di "Starsky e Hutch" e che qui si rivela scelta felice, il giovane e vendicativo Mark Petrie, l'inesperta e naif Susan Norton; e sopratutto Straker, la cui caratterizzazione viene resa ancora più sottile e il cui ruolo viene affidato all'immenso James Mason, che riplasma il personaggio in un misto di cattiveria viscerale e sottomissione al suo "padrone", quel Barlow che qui viene spogliato da qualsiasi influenza del Dracula filmico per rifarsi a "Nosferatu il Vampiro" (1922) di Murnau, divenendo una figura mostruosa ed incredibilmente spaventosa. Uniche perdite sono i personaggi di Padre Callahan e Matt Burke: il primo fa una semplice comparsata ed il suo calvario fatto di fede non proprio ferrea e dipendenza dalla bottiglia è assente, mentre il seondo, ribattezzato "Jason", non ha il ruolo di novello Van Helsing che aveva nel libro.
La natura televisiva ha purtroppo fatto invecchiare male l'opera di Hooper. Gli scarsi valori produttivi si riverberano non tanto sugli effetti, che invece sfoggiano una cura inusuale ed ancora efficace, quanto nella messa in scena, molto semplice, talvolta fatta una sola inquadratura per scena ed afflitta da una fotografia scarna.
Di tutt'altro livello sono le sequenze squisitamente d'orrore, nel quale Hooper dà provadi grande maestria. La scena del ritorno del piccolo Danny Glick dal fratello, sotto forma di succhiasangue, stupisce per carica visionaria. Ma è l'entrata in scena di Barlow a costituire il pezzo forte del film: un primo piano voltato a jump-scare che gela il sangue nelle vene, semplicemente da manuale. Così come da antologia è la sequenza della sua distruzione: tesa quasi fino alla disperazione ed incredibilmente espressiva. Monash ed Hooper riescono poi semplificare la conclusione del romanzo senza perdere un'unghia della sua carica di tensione ed aggiungo un epilogo cattivo ed ancora più spiazzante di quello del libro.
In generale, a stupire è la capacità dei due autori di trasporre il senso di terrore sottile e strisciante che permea il romanzo, nonchè il senso di cupezza e tensione utilizzando le basi della messa in scena.
Il successo della mini-serie (due episodi da 90 minuti ciascuno) all'epoca fu notevole, tanto che ne venne creata anche una versione cinematografica da 104 minuti. Per forza di cose, molti degli elementi descrittivi e delle sottotrame sono state eliminate, ma anche questa versione risulta interessante e inquietante, anche grazie agli effetti splatter aggiunti alle scene più cruente.
Naturalmente, la visione della versione integrale resta preferibile, sopratutto per comprendere l'ottima opera di adattamento di Monash, che per una volta pare che non scontentò neanche King.
EXTRA
Nel 2004, l'emittente via cavo TNT ha prodotto un nuovo adattamento di "Salem's Lot". Nonostante un cast di prim'ordine, composta da Rob Lowe, Donald Sutherland, James Cromwell e Rutger Hauer, questa nuova versione non è ai livelli dell'originale di Hooper, a causa della sceneggiatura, questa volta troppo rispettosa del testo originario e della regia piatta e poco ispirata.
martedì 22 settembre 2015
Star Wars- Episodio I- La Minaccia Fantasma
Star Wars- Episode I- The Phantom Menace
di George Lucas.
con: Liam Neeson, Ewan McGregor, Natalie Portman, Jake Lloyd, Ian McDiarmid, Ray Park, Terence Stamp, Ahmed Best, Anthony Daniels, Kenny Baker. Brian Bleseed, Frank Oz, Samuel L.Jackson.
Fantastico/Avventura
Usa, 1999
16 anni dopo "Il Ritorno dello Jedi" (1983), George Lucas non è più l'artista sperimentatore che si è formato presso Coppola e che aborrisce l'abuso di effetti speciali. Già l'esperienza con l'ultimo capitolo della sua amata saga ha dimostrato la sua metamorfosi, ma "La Minaccia Fantasma" sancisce la sua mutazione totale nel peggior filmaker che Hollywood conosca: un autore incapace di creare una storia credibile o dei personaggi carismatici perchè interessato unicamente a giocare con i prodigi della tecnologia.
Di acqua sotto i ponti, tra il 1983 ed il 1999, ne è passata, non c'è dubbio. Ma poco o nulla lasciava presagire il pozzo nero che lo avrebbe inghiottito. Basti pensare che la sua carriera di produttore negli anni '80 era stata tutto sommato rosea: la saga di Indiana Jones (1981-1989), pilastro della cultura pop impregnata di un vero senso della nostalgia per un cinema ludico, ma incredibilmente espressivo; la parentesi fantasy di "Willow" (1986), omaggio all'amato Tolkien che riprende i topoi del primo "Guerre Stellari" (1977) declinandoli in chiave squisitamente fantasy. L'impegno, assieme a Francis Coppola, per distribuire in occidente i capolavori dell'amato Akira Kurosawa "Kagemusha" (1980) e "Ran" (1985). Persino il fallimento di "Howard the Duck" (1986) lasciava intendere una volontà di sperimentare ed osare sul piano contenutistico che con "La Minaccia Fantasma" sarebbe sparita.
Questo perchè il nuovo exploit della "Galassia lontana lontana" non ha nulla a che vedere con le ispirazioni primordiali del suo autore; niente più jidai-geki o Kurosawa, niente più cinema d'avventura o sci-fi d'antàn, ne riferimenti letterari colti. La "nuova trilogia" si inserisce perfettamente nel clima hollywoodiano contemporaneo, nel quale non c'è spazio per i contenuti, solo per gli effetti, non devono esserci storie, ma solo prodotti vendibili. Ed i risultati si vedono a partire dal titolo del film: "Star Wars- Episodio I", ossia uno di una serie, un prodotto che da solo non può avere dignità ma che esiste solo in relazione ad un franchise, ad altri prodotti che vengono venduti separatamente, creati solo per essere a loro volta venduti in quanto parti di un tutto.
Non è stato certo George Lucas ad imprimere la svolta trash al cinema spettacolare americano. Per tutti gli anni '90, registi del calibro di Roland Hemmerich o Wolgang Petersen si sono impegnati a rendere di volta in volta il blockbuster di turno sempre più grande e al contempo più idiota, con trame implausibili e personaggi piatti o, peggio, irritanti. Quando Lucas ha presentato al pubblico il nuovo ciclo di "Guerre Stellari", questi aveva già avuto a che fare più e più volte con kolossal idioti ai limiti del becero. "Episodio I" ha "semplicemente" alzato l'asticella dell'idiozia ad un nuovo livello: non solo la trama non ha senso e i personaggi sono inesistenti, ma persino gli effetti speciali sono talmente finti da sconfinare nel cinema d'animazione.
Non c'è davvero nulla che funzioni in questo nuovo capitolo della saga pseudo sci-fi più amata di sempre. A partire dal setting, che si concilia malissimo con i film precedenti: "Episodio I" ed i suoi due seguiti non hanno nulla a che vedere con gli originali dal punto di vista dell'ambientazione e dell'estetica. Laddove i film della "trilogia originale" riuscivano a creare un mondo ameno, ma vivo, dove la tecnologia era sporca, logora per l'uso e per questo credibile, il mondo della "nuova trilogia" è talmente lucente e sbrillucicante da far male agli occhi e far credere come in questo strambo universo la tecnologia tenda a peggiore piuttosto che ad evolversi.
Sul piano narrativo le cose non vanno meglio: nessuna delle premesse del primo "Guerre Stellari" viene rispettata. L'Ordine degli Jedi veniva lì definito come "un'antica religione" i cui fasti sono stati obliati dal tempo, ma qui, appena trent'anni prima, gli Jedi sono vivi e prosperi, e più che una religione ricordano un antico ordine cavalleresco. Come sia possibile che il loro ricordo venga cancellato in così poco tempo non è dato saperlo. L'incongruenza più contestata dai fans è anche la più squallida: la Forza non è più un'energia mistica che unisce ogni singolo corpo nell'Universo, ma l'emanazione di particelle subcellulari, i "midiclorian", che conferiscono dei superpoteri a chi li possiede in gran numero; spiegazione pararazionale e pseudoscientifica che tutto sommato potrebbe anche funzionare; finchè Lucas non tenta di far credere allo spettatore come questi corpuscoli abbiano addirittura concepito un bambino con una donna, neanche fossero una sorta di Spirito Santo mitocondriale, in un trionfo di incredulità e trovate ridicole.
Tutti i personaggi sono blandi e agiscono in modo stupido. Se nei vecchi film i protagonisti rivestivano ruolo archetipici o svecchiavano vecchi luoghi comuni del cinema avventuroso, qui non sono che marionette utili solo a far procede l'esilissima storia da un punto A ad un punto B. Non c'è un cammino dell'eroe, un'evoluzione, una presa di coscienza, ma neanche la più semplice e basica caratterizzazione. Si parte con il Qui-Gon Jinn di Liam Neeson, sorta di Obi Wan ante literam, depositario della saggezza che con la sua enciclopedica conoscenza della Forza non riesce a fiutare le trappole neanche quando vi cade dentro; forse la capacità di predire il futuro all'epoca non era stata ancora inventata. Obi Wan, qui con il volto di Ewan McGregor, resta sullo sfondo degli eventi, una figurina messa lì solo per dare una sbiadita continuità alla saga. La regina Padmè di Natalie Portman non può neanche essere definita "personaggio": cambia look in ogni singola scena in cui appare, non ha tratti caratteriali marcati o riconoscibili, né sembra avere le capacità riflessive o conoscitive che la carica politica dovrebbe richiedere. Il villain Darth Maul di Ray Park serve solo per dare un avversario da combattere, così come la squallida Federazione dei Mercanti. C3PO e R2D2 compaiono in modo improbabile: il primo è un androide costruito da Anakin per aiutare la madre nelle faccende domestiche, peccato che le sue funzioni di traduttore l'incapacità di muovere le braccia lo rendano del tutto inutile nell'affiancare uno schiavo; il secondo è addirittura un'unità riparatrice che sopravvive ad un attacco in pieno spazio, quando nei vecchi film si limitava a fare da copilota.
E poi ci sono loro, il piccolo Anakin e Jar Jar Binks, motivo d'ira di tutti i fans. E a ben ragione: sono personaggi inutili e fastidiosi. Perchè Anakin deve essere un bambino? Che senso ha far cominciare la storia con lui ancora infante e lontano dal cammino dell'apprendistato? Nessuno, solo la volontà di creare un film-primo atto totalmente introduttivo e colmarlo con qualsiasi cosa pur di celare l'endemica mancanza di idee.
Jar Jar Binks è il punto più basso toccato dalla scrittura di Lucas: un personaggio inutile, una spalla comica che non fa mai ridere, le cui gag splastick sono fastidiose, la parlantina stramba perfora le orecchie e distrugge il cervello dello spettatore e lo sguardo da idiota evoca pensieri violenti piuttosto che gioiosi. Lucas può andare sicuramente fiero del fatto di aver dato vita ad una creatura totalmente digitale che interagisce con attori in carne ed ossa, ma chiamarlo "personaggio" è un insulto a chi i personaggi sa scriverli.
Ed è davvero imbarazzante vedere attori del calibro di Neeson, della Portman e finanche di Terence Stamp imbacuccati in costumi improbabili recitare dialoghi privi di senso e mordente, con uno sguardo disorientato a causa dell'abuso di green-screen.
Il canovaccio scritto da Lucas non si regge in piedi. La premessa è vacua e priva di senso: per protestare contro l'introduzione di una tassa, la Federazione Mercantile invade il pianeta Naboo. Perchè proprio Naboo? Perchè l'introduzione di una tassa porta una gilda di mercanti ad assediare un intero pianeta? E sopratutto: come è possibile che in un periodo di pace in cui la galassia è governata da una repubblica democratica, ad una federazione di mercanti sia concessa la possibilità di avere un enorme esercito di droidi armati fino ai denti?
Inutile cercare di raccapezzarcisi: la storiella alla base di tutto è solo un pretesto per far muovere i personaggi da un punto A ad un punto B, ossia da Naboo a Coruscant e ritorno, passando per Tatooine.
La parte centrale, ambientata sul pianeta desertico, riserva i passaggi più imbarazzanti. Anakin e la madre Shmi vengono introdotti come schiavi controllati con un esplosivo nascosto nel loro corpo. Forse Lucas non ha mai sentito parlare di schiavi o forse pensa che la loro vita tutto sommato non sia malaccio, fatto sta che questi due schiavi hanno una casa propria, degli averi e non sono neanche oberati dal lavoro. Anakin vince la libertà nella famosa corsa degli sgusci, sequenza che da sola contiene tutti i difetti del film: grande e pacchiana, non riesce ad intrattenere perchè priva di vera tensione; data la natura di prequel del film lo spettatore ne conosce già l'esito, ma Lucas non fa nulla per renderla davvero avvincente, salvo caricarla di tutti gli effetti speciali possibili ed immaginabili. Finita la corsa, Anakin è libero, ma la madre resta schiava su Tatooine per sempre, visto che nei film successivi il figliol prodigo si dimenticherà di andare a salvarla.
E come ne "Il Ritorno dello Jedi" (1983), è nel terzo atto che l' "epopea" di Lucas si affloscia definitivamente; qui le battaglie sono ben quattro: la guerra tra i Gungan e i droidi, lo scontro stellare tra i piloti e le navi della Federazione, lo scontro a fuoco tra gli uomini di Padmé e le truppe terrestri ed il "triello" tra i due jedi ed il sith. Troppa carne al fuoco, gestita anche male. Come al solito, non c'è tensione: lo scontro tra i Gungan ed i droidi sembra un cartone animato per estetica e coreografia, con in più gli squallidi siparietti di Jar Jar a fare da contorno. La guerriglia di Padmè è stanca e basica nell'esecuzione, mentre l'attacco alle navi spaziali sa di già visto. Il triello merita menzione a parte: Lucas gestisce tutto come un wuxia pin da quattro soldi, con coreografie studiate al millimetro, ma prive della più basica fisicità. I tre attori ballano, più che combattere, il pathos latita nonostante le belle note dello score di John Williams e persino la dipartita di Qui-Gon lascia freddi.
Su tutto, è l'estetica a turbare maggiormente: la CGI e l'abuso di color correction fanno calare una patina di falsità su ogni singola scena. Ogni frame non solo è fasullo, ma dalla fotografia talmente alterata da scadere nel brutto. Senza contare come la costruzione della scena da parte di Lucas è qui talmente basica da sembrare il lavoro di un pivello, piuttosto che quello di un veterano della New Wave.
Ed alla fine, il flop è servito: "La Minaccia Fantasma" non solo è giustamente ricordato come la prima falla nell'immaginario di "Star Wars", ma rappresenta anche un importante punto di svolta nella concezione del blockbuster hollywoodiano; da adesso in poi i filmakers dietro i blockbuster tenderanno sempre più spesso non solo a glissare su personaggi e storia, ma anche a risparmiare sul set, arrivando ad utilizzare il green-screen per ogni singolo elemento scenografico, creando film sempre più patinati e piatti, lontani dall'estetica cinematografica e più vicini a quella dell'animazione o, peggio, del videogame.
EXTRA
Sarebbe impensabile modificare gli effetti speciali di un film uscito "solo" nel 1999. Ma non per George Lucas, che in occasione dell'edizione in Blu-Ray Disc del film ha deciso di sostituire l'animatronico di Yoda con un pupazzo in CGI decisamente meno credibile.
10 anni dopo l'uscita in sala, il fandom di tutto il mondo ancora non riusciva a capacitarsi dell'incredibile crollo qualitativo della saga di "Guerre Stellari". Il giovane regista Kyle Newman, in quel 2009, decise di omaggiare i fanatici lucasiani con "Fanboys", divertente commedia sulle ossessioni geek di un'intera generazione cresciuta a pane e Luke Skywalker. Nonostante un umorismo non sempre ispirato e passaggi che avrebbero meritato maggiore spazio (su tutti la guerra con i "Trekkers"), "Fanboys" è una visione disimpegnata e simpatica, preferibile ai nuovi film di Lucas.
di George Lucas.
con: Liam Neeson, Ewan McGregor, Natalie Portman, Jake Lloyd, Ian McDiarmid, Ray Park, Terence Stamp, Ahmed Best, Anthony Daniels, Kenny Baker. Brian Bleseed, Frank Oz, Samuel L.Jackson.
Fantastico/Avventura
Usa, 1999
16 anni dopo "Il Ritorno dello Jedi" (1983), George Lucas non è più l'artista sperimentatore che si è formato presso Coppola e che aborrisce l'abuso di effetti speciali. Già l'esperienza con l'ultimo capitolo della sua amata saga ha dimostrato la sua metamorfosi, ma "La Minaccia Fantasma" sancisce la sua mutazione totale nel peggior filmaker che Hollywood conosca: un autore incapace di creare una storia credibile o dei personaggi carismatici perchè interessato unicamente a giocare con i prodigi della tecnologia.
Di acqua sotto i ponti, tra il 1983 ed il 1999, ne è passata, non c'è dubbio. Ma poco o nulla lasciava presagire il pozzo nero che lo avrebbe inghiottito. Basti pensare che la sua carriera di produttore negli anni '80 era stata tutto sommato rosea: la saga di Indiana Jones (1981-1989), pilastro della cultura pop impregnata di un vero senso della nostalgia per un cinema ludico, ma incredibilmente espressivo; la parentesi fantasy di "Willow" (1986), omaggio all'amato Tolkien che riprende i topoi del primo "Guerre Stellari" (1977) declinandoli in chiave squisitamente fantasy. L'impegno, assieme a Francis Coppola, per distribuire in occidente i capolavori dell'amato Akira Kurosawa "Kagemusha" (1980) e "Ran" (1985). Persino il fallimento di "Howard the Duck" (1986) lasciava intendere una volontà di sperimentare ed osare sul piano contenutistico che con "La Minaccia Fantasma" sarebbe sparita.
Questo perchè il nuovo exploit della "Galassia lontana lontana" non ha nulla a che vedere con le ispirazioni primordiali del suo autore; niente più jidai-geki o Kurosawa, niente più cinema d'avventura o sci-fi d'antàn, ne riferimenti letterari colti. La "nuova trilogia" si inserisce perfettamente nel clima hollywoodiano contemporaneo, nel quale non c'è spazio per i contenuti, solo per gli effetti, non devono esserci storie, ma solo prodotti vendibili. Ed i risultati si vedono a partire dal titolo del film: "Star Wars- Episodio I", ossia uno di una serie, un prodotto che da solo non può avere dignità ma che esiste solo in relazione ad un franchise, ad altri prodotti che vengono venduti separatamente, creati solo per essere a loro volta venduti in quanto parti di un tutto.
Non è stato certo George Lucas ad imprimere la svolta trash al cinema spettacolare americano. Per tutti gli anni '90, registi del calibro di Roland Hemmerich o Wolgang Petersen si sono impegnati a rendere di volta in volta il blockbuster di turno sempre più grande e al contempo più idiota, con trame implausibili e personaggi piatti o, peggio, irritanti. Quando Lucas ha presentato al pubblico il nuovo ciclo di "Guerre Stellari", questi aveva già avuto a che fare più e più volte con kolossal idioti ai limiti del becero. "Episodio I" ha "semplicemente" alzato l'asticella dell'idiozia ad un nuovo livello: non solo la trama non ha senso e i personaggi sono inesistenti, ma persino gli effetti speciali sono talmente finti da sconfinare nel cinema d'animazione.
Non c'è davvero nulla che funzioni in questo nuovo capitolo della saga pseudo sci-fi più amata di sempre. A partire dal setting, che si concilia malissimo con i film precedenti: "Episodio I" ed i suoi due seguiti non hanno nulla a che vedere con gli originali dal punto di vista dell'ambientazione e dell'estetica. Laddove i film della "trilogia originale" riuscivano a creare un mondo ameno, ma vivo, dove la tecnologia era sporca, logora per l'uso e per questo credibile, il mondo della "nuova trilogia" è talmente lucente e sbrillucicante da far male agli occhi e far credere come in questo strambo universo la tecnologia tenda a peggiore piuttosto che ad evolversi.
Sul piano narrativo le cose non vanno meglio: nessuna delle premesse del primo "Guerre Stellari" viene rispettata. L'Ordine degli Jedi veniva lì definito come "un'antica religione" i cui fasti sono stati obliati dal tempo, ma qui, appena trent'anni prima, gli Jedi sono vivi e prosperi, e più che una religione ricordano un antico ordine cavalleresco. Come sia possibile che il loro ricordo venga cancellato in così poco tempo non è dato saperlo. L'incongruenza più contestata dai fans è anche la più squallida: la Forza non è più un'energia mistica che unisce ogni singolo corpo nell'Universo, ma l'emanazione di particelle subcellulari, i "midiclorian", che conferiscono dei superpoteri a chi li possiede in gran numero; spiegazione pararazionale e pseudoscientifica che tutto sommato potrebbe anche funzionare; finchè Lucas non tenta di far credere allo spettatore come questi corpuscoli abbiano addirittura concepito un bambino con una donna, neanche fossero una sorta di Spirito Santo mitocondriale, in un trionfo di incredulità e trovate ridicole.
Tutti i personaggi sono blandi e agiscono in modo stupido. Se nei vecchi film i protagonisti rivestivano ruolo archetipici o svecchiavano vecchi luoghi comuni del cinema avventuroso, qui non sono che marionette utili solo a far procede l'esilissima storia da un punto A ad un punto B. Non c'è un cammino dell'eroe, un'evoluzione, una presa di coscienza, ma neanche la più semplice e basica caratterizzazione. Si parte con il Qui-Gon Jinn di Liam Neeson, sorta di Obi Wan ante literam, depositario della saggezza che con la sua enciclopedica conoscenza della Forza non riesce a fiutare le trappole neanche quando vi cade dentro; forse la capacità di predire il futuro all'epoca non era stata ancora inventata. Obi Wan, qui con il volto di Ewan McGregor, resta sullo sfondo degli eventi, una figurina messa lì solo per dare una sbiadita continuità alla saga. La regina Padmè di Natalie Portman non può neanche essere definita "personaggio": cambia look in ogni singola scena in cui appare, non ha tratti caratteriali marcati o riconoscibili, né sembra avere le capacità riflessive o conoscitive che la carica politica dovrebbe richiedere. Il villain Darth Maul di Ray Park serve solo per dare un avversario da combattere, così come la squallida Federazione dei Mercanti. C3PO e R2D2 compaiono in modo improbabile: il primo è un androide costruito da Anakin per aiutare la madre nelle faccende domestiche, peccato che le sue funzioni di traduttore l'incapacità di muovere le braccia lo rendano del tutto inutile nell'affiancare uno schiavo; il secondo è addirittura un'unità riparatrice che sopravvive ad un attacco in pieno spazio, quando nei vecchi film si limitava a fare da copilota.
E poi ci sono loro, il piccolo Anakin e Jar Jar Binks, motivo d'ira di tutti i fans. E a ben ragione: sono personaggi inutili e fastidiosi. Perchè Anakin deve essere un bambino? Che senso ha far cominciare la storia con lui ancora infante e lontano dal cammino dell'apprendistato? Nessuno, solo la volontà di creare un film-primo atto totalmente introduttivo e colmarlo con qualsiasi cosa pur di celare l'endemica mancanza di idee.
Jar Jar Binks è il punto più basso toccato dalla scrittura di Lucas: un personaggio inutile, una spalla comica che non fa mai ridere, le cui gag splastick sono fastidiose, la parlantina stramba perfora le orecchie e distrugge il cervello dello spettatore e lo sguardo da idiota evoca pensieri violenti piuttosto che gioiosi. Lucas può andare sicuramente fiero del fatto di aver dato vita ad una creatura totalmente digitale che interagisce con attori in carne ed ossa, ma chiamarlo "personaggio" è un insulto a chi i personaggi sa scriverli.
Ed è davvero imbarazzante vedere attori del calibro di Neeson, della Portman e finanche di Terence Stamp imbacuccati in costumi improbabili recitare dialoghi privi di senso e mordente, con uno sguardo disorientato a causa dell'abuso di green-screen.
Il canovaccio scritto da Lucas non si regge in piedi. La premessa è vacua e priva di senso: per protestare contro l'introduzione di una tassa, la Federazione Mercantile invade il pianeta Naboo. Perchè proprio Naboo? Perchè l'introduzione di una tassa porta una gilda di mercanti ad assediare un intero pianeta? E sopratutto: come è possibile che in un periodo di pace in cui la galassia è governata da una repubblica democratica, ad una federazione di mercanti sia concessa la possibilità di avere un enorme esercito di droidi armati fino ai denti?
Inutile cercare di raccapezzarcisi: la storiella alla base di tutto è solo un pretesto per far muovere i personaggi da un punto A ad un punto B, ossia da Naboo a Coruscant e ritorno, passando per Tatooine.
La parte centrale, ambientata sul pianeta desertico, riserva i passaggi più imbarazzanti. Anakin e la madre Shmi vengono introdotti come schiavi controllati con un esplosivo nascosto nel loro corpo. Forse Lucas non ha mai sentito parlare di schiavi o forse pensa che la loro vita tutto sommato non sia malaccio, fatto sta che questi due schiavi hanno una casa propria, degli averi e non sono neanche oberati dal lavoro. Anakin vince la libertà nella famosa corsa degli sgusci, sequenza che da sola contiene tutti i difetti del film: grande e pacchiana, non riesce ad intrattenere perchè priva di vera tensione; data la natura di prequel del film lo spettatore ne conosce già l'esito, ma Lucas non fa nulla per renderla davvero avvincente, salvo caricarla di tutti gli effetti speciali possibili ed immaginabili. Finita la corsa, Anakin è libero, ma la madre resta schiava su Tatooine per sempre, visto che nei film successivi il figliol prodigo si dimenticherà di andare a salvarla.
E come ne "Il Ritorno dello Jedi" (1983), è nel terzo atto che l' "epopea" di Lucas si affloscia definitivamente; qui le battaglie sono ben quattro: la guerra tra i Gungan e i droidi, lo scontro stellare tra i piloti e le navi della Federazione, lo scontro a fuoco tra gli uomini di Padmé e le truppe terrestri ed il "triello" tra i due jedi ed il sith. Troppa carne al fuoco, gestita anche male. Come al solito, non c'è tensione: lo scontro tra i Gungan ed i droidi sembra un cartone animato per estetica e coreografia, con in più gli squallidi siparietti di Jar Jar a fare da contorno. La guerriglia di Padmè è stanca e basica nell'esecuzione, mentre l'attacco alle navi spaziali sa di già visto. Il triello merita menzione a parte: Lucas gestisce tutto come un wuxia pin da quattro soldi, con coreografie studiate al millimetro, ma prive della più basica fisicità. I tre attori ballano, più che combattere, il pathos latita nonostante le belle note dello score di John Williams e persino la dipartita di Qui-Gon lascia freddi.
Su tutto, è l'estetica a turbare maggiormente: la CGI e l'abuso di color correction fanno calare una patina di falsità su ogni singola scena. Ogni frame non solo è fasullo, ma dalla fotografia talmente alterata da scadere nel brutto. Senza contare come la costruzione della scena da parte di Lucas è qui talmente basica da sembrare il lavoro di un pivello, piuttosto che quello di un veterano della New Wave.
Ed alla fine, il flop è servito: "La Minaccia Fantasma" non solo è giustamente ricordato come la prima falla nell'immaginario di "Star Wars", ma rappresenta anche un importante punto di svolta nella concezione del blockbuster hollywoodiano; da adesso in poi i filmakers dietro i blockbuster tenderanno sempre più spesso non solo a glissare su personaggi e storia, ma anche a risparmiare sul set, arrivando ad utilizzare il green-screen per ogni singolo elemento scenografico, creando film sempre più patinati e piatti, lontani dall'estetica cinematografica e più vicini a quella dell'animazione o, peggio, del videogame.
EXTRA
Sarebbe impensabile modificare gli effetti speciali di un film uscito "solo" nel 1999. Ma non per George Lucas, che in occasione dell'edizione in Blu-Ray Disc del film ha deciso di sostituire l'animatronico di Yoda con un pupazzo in CGI decisamente meno credibile.
10 anni dopo l'uscita in sala, il fandom di tutto il mondo ancora non riusciva a capacitarsi dell'incredibile crollo qualitativo della saga di "Guerre Stellari". Il giovane regista Kyle Newman, in quel 2009, decise di omaggiare i fanatici lucasiani con "Fanboys", divertente commedia sulle ossessioni geek di un'intera generazione cresciuta a pane e Luke Skywalker. Nonostante un umorismo non sempre ispirato e passaggi che avrebbero meritato maggiore spazio (su tutti la guerra con i "Trekkers"), "Fanboys" è una visione disimpegnata e simpatica, preferibile ai nuovi film di Lucas.
venerdì 18 settembre 2015
Ultracorpi- L'Invasione Continua
Body Snatchers
di Abel Ferrara.
con: Gabrielle Anwar, Terry Kinney, Billy Wirth, R.Lee Ermey, Meg Tilly, Forest Whitaker, Christine Elise.
Fantascienza/Horror
Usa-1993
---CONTIENE SPOILERS---
L'ultracorpo di Ferrara è l'esponente di una civiltà del tutto opposta a quella umana, sicuramente non migliore, ma neanche automaticamente peggiore; la cancellazione dei conflitti mediante la soppressione delle emozioni è un fine ai limiti dell'altruistico: la colonizzazione silenziosa mira non alla semplice sostituzione dell'essere umano con un suo doppio privo di emozioni e totalmente regolato dalla logica più basilare (da qui la necessaria preferenza del termine italiano "ultracorpo", ossia "corpo altro", inteso come dissociazione dell'essere umano da parte sé, molto più calzante dell'originale "body snatcher", letteralmente "scippatore di corpi"), bensì alla creazione di una nuova umanità che si autoregoli mediante la sola funzione cerebrale.
La scelta di ambientare la vicenda in una base militare diviene caratteristica vincente che permette di donarle un ulteriore significato.
L'istituzione militare viene illuminata di una duplice accezione; da un lato come emblema della stessa umanità, impegnata in attività ottusamente distruttive, come la guerra chimica della padre di Marty è chiamato a valutare gli effetti in tempi in pace. Dall'altra, la personificazione stessa della "nuova società" in via di formazione da parte dei coloni alieni; una società nella quale l'individuo non può esistere se non come unità frazionata del tutto, dove il singolo corpo deve essere necessariamente ricondotto al corpo sociale; proprio come nell'esercito, dove il singolo soldato non è che un'appendice di un gigantesco organismo, a suo modo sacrificabile e sostituibile da un altro poichè privo di effettiva individualità. Il concetto di omologazione nella sua accezione più terribile trova così una sua perfetta personificazione.
Nel portare in scena la vicenda, Ferrara decide di eliminare i personaggi più forti: il pater familias di Terry kinney ha un ruolo ai limiti dell'ancillare, mentre l'ufficiale medico di Whitaker, il primo ad accorgersi dell'invasione, viene relegato nei confini della paranoia.
Protagonisti assoluti sono la giovane Marty, interpretata dalla bellissima Gabirelle Anwar, suo fratello Andy, ancora bambino, ed il giovane pilota Tim, ossia gente comune, per di più giovane, lontana dal potere decisionale che solitamente la società militare concede agli ufficiali e quella civile ai membri attivi.
Scindendo la vicenda in due parti, Ferrara costruisce l'incipit quasi come una favola horror, nella quale l'orrore strisciante viene dapprima visto solo di sguincio dal piccolo Andy, come l'incubo di un bambino. La scelta del punto di vista di Andy, Marty e, in parte, di loro padre coincide con una messa in scena perlopiù in soggettiva, dove lo spettatore è chiamato ad attraversare gli ambienti e ad assistere alla follia dilagante direttamente con gli occhi dei personaggi; mentre si avvicina a questi con i soliti, magnifici, primi piani che distinguevano il cinema di Ferrara dell'epoca, talmente espressivi da rendere gli attori ancora più vivi. Nella seconda parte, il caos si espande e la lotta per la sopravvivenza contro l'omologazione diviene imperativa.
La costruzione della tensione nella prima parte è da manuale: alle prese con un genere solo sfiorato, Ferrara dimostra un'ottima dimestichezza nel creare suspanse e sopratutto nel farla esplodere all'improvviso, come nella scena in cui Andy scopre il simulacro della madre. Da antologia la fotografia del fido Bojan Bazzelli, che usa le tenebre per dipingere ogni singolo ambiente, contrastando ogni scena in modo netto ed espressivo. Persino la direzione di un duo di attori inesperti, la Anwar e Wirth, riesce a sopperire alle mancanze della sceneggiatura e a far respirare due personaggi ai quali, su carta, veniva concesso poco spazio per l'introspezione.
Dismessi i baccelli vegetali del classico di Siegel, gli ultracorpi di Ferrara sono i più viscerali mai apparsi su schermo. La fagocitazione del corpo estraneo avviene ora con tentacoli che avvinghiano la vittima, mentre in un vero e proprio utero una nuova vita viene creata. Non c'è quasi nessuna differenza, sul piano biologico, tra l'originale e la copia: anche l'invasore ha qui la dignità di un essere vivente. Tanto che nell'epilogo, la "giusta vendetta" di Andy, novella Thana qui chiamata a riscattare l'umanità tutta, si colora di una nota truce, nella quale l'orrore dello sterminio gratuito e feroce cancella ogni effettiva forma di giustizia. Il massacro operato dagli umani non è meno sconvolgente dell'omologazione aliena, facendo risaltare tutta la brutalità di cui l'uomo è capace. La contrapposizione tra creature di puro intelletto e animali civilizzati non ha così né vincitori né vinti, non finisce a causa di un finale aperto che mima quello dei due film precedente, senza purtroppo eguagliarne la carica distruttiva, ma lasciando comunque lo spettatore scosso, nella scomoda posizione di valutare tutto l'orrore al quale ha assistito: l'orrore di un mondo in preda alla cieca violenza, l'orrore di un mondo pacifico, ma privo di vita.
Elegante ed inquietante, "Body Snatchers" è un piccolo esempio di cinema commerciale che nelle mani dell'autore giusto riesce ad essere più profondo di quanto ci si potrebbe aspettare. Di certo non un capolavoro, ma una piccola gemma che merita di essere riscoperta. Sopratutto a seguito dell'infausta visione di "Invasion" (2006), ultimo e peggiore adattamento del romanzo di Finney, che grida vendetta.
di Abel Ferrara.
con: Gabrielle Anwar, Terry Kinney, Billy Wirth, R.Lee Ermey, Meg Tilly, Forest Whitaker, Christine Elise.
Fantascienza/Horror
Usa-1993
---CONTIENE SPOILERS---
All'indomani dell'uscita de "Il Cattivo Tenente" (1992), Abel Ferrara non era più considerato un semplice artista di genere, ma un autore maturo, in grado di dar vita alle proprie ossessioni in modo fulgido e viscerale mediante uno stile personale e privo di compromessi.
Cosa lo abbia portato a riallacciare i rapporti con il cinema di genere a tutto tondo non è dato saperlo. Fatto sta che, appena un anno dopo aver firmato il suo più intimo capolavoro, si ritrova alla regia di "Body Snatchers", curioso spin-off del romanzo di Jack Finney in cantiere presso la Warner. Ma i tempi di "Cat Chaser" (1989) sono fortunatamente lontani: pur approcciandosi ad una materia non sua ed ad una sceneggiatura già in larga parte scritta, Ferrara riesce ad imporre la sua visione nella pellicola e a creare un film di sicuro non memorabile, ma totalmente riuscito, un b-movie nato con sole pretese di cassetta dalla quale emergono riflessioni urgenti, proprie del cinema d'autore più rigoroso.
Cosa lo abbia portato a riallacciare i rapporti con il cinema di genere a tutto tondo non è dato saperlo. Fatto sta che, appena un anno dopo aver firmato il suo più intimo capolavoro, si ritrova alla regia di "Body Snatchers", curioso spin-off del romanzo di Jack Finney in cantiere presso la Warner. Ma i tempi di "Cat Chaser" (1989) sono fortunatamente lontani: pur approcciandosi ad una materia non sua ed ad una sceneggiatura già in larga parte scritta, Ferrara riesce ad imporre la sua visione nella pellicola e a creare un film di sicuro non memorabile, ma totalmente riuscito, un b-movie nato con sole pretese di cassetta dalla quale emergono riflessioni urgenti, proprie del cinema d'autore più rigoroso.
Il romanzo di Finney era già comparso due volte su schermo; la prima nel 1956, con il classico "L'Invasione degli Ultracorpi" diretto da Don Siegel, vero e proprio manifesto della fantascienza paranoica dell'epoca, nel quale i famosi "baccelloni alieni" erano la metafora del "pericolo rosso" che si infiltrava silenzioso nella società americana per fagocitarla lentamente. Nel 1978 è la volta del remake di Philip Kaufman, "Terrore dallo Spazio Profondo", nel quale l'orrore diviene più viscerale, in una sorta di body horror nel quale il tema del doppio viene declinato come metafora di una società annichilente.
Ferrara, dal canto suo, non si rifà a nessuno dei predecessori, avvicinandosi nello spirito a quello che era il tema del romanzo: la distruzione dell'emozione umana come forma di liberazione dell'individuo dalla violenza, controbilanciata dalla perdita dell'individualità.
Lo script, rimaneggiato dal fido Nicolas St.John e sul quale aveva precedentemente lavorato anche Stuart Gordon, sposta l'ambientazione dalla sonnolenta provincia americana ad una base militare, introducendo una forte metafora antimilitarista.
L'ultracorpo di Ferrara è l'esponente di una civiltà del tutto opposta a quella umana, sicuramente non migliore, ma neanche automaticamente peggiore; la cancellazione dei conflitti mediante la soppressione delle emozioni è un fine ai limiti dell'altruistico: la colonizzazione silenziosa mira non alla semplice sostituzione dell'essere umano con un suo doppio privo di emozioni e totalmente regolato dalla logica più basilare (da qui la necessaria preferenza del termine italiano "ultracorpo", ossia "corpo altro", inteso come dissociazione dell'essere umano da parte sé, molto più calzante dell'originale "body snatcher", letteralmente "scippatore di corpi"), bensì alla creazione di una nuova umanità che si autoregoli mediante la sola funzione cerebrale.
La scelta di ambientare la vicenda in una base militare diviene caratteristica vincente che permette di donarle un ulteriore significato.
L'istituzione militare viene illuminata di una duplice accezione; da un lato come emblema della stessa umanità, impegnata in attività ottusamente distruttive, come la guerra chimica della padre di Marty è chiamato a valutare gli effetti in tempi in pace. Dall'altra, la personificazione stessa della "nuova società" in via di formazione da parte dei coloni alieni; una società nella quale l'individuo non può esistere se non come unità frazionata del tutto, dove il singolo corpo deve essere necessariamente ricondotto al corpo sociale; proprio come nell'esercito, dove il singolo soldato non è che un'appendice di un gigantesco organismo, a suo modo sacrificabile e sostituibile da un altro poichè privo di effettiva individualità. Il concetto di omologazione nella sua accezione più terribile trova così una sua perfetta personificazione.
Nel portare in scena la vicenda, Ferrara decide di eliminare i personaggi più forti: il pater familias di Terry kinney ha un ruolo ai limiti dell'ancillare, mentre l'ufficiale medico di Whitaker, il primo ad accorgersi dell'invasione, viene relegato nei confini della paranoia.
Protagonisti assoluti sono la giovane Marty, interpretata dalla bellissima Gabirelle Anwar, suo fratello Andy, ancora bambino, ed il giovane pilota Tim, ossia gente comune, per di più giovane, lontana dal potere decisionale che solitamente la società militare concede agli ufficiali e quella civile ai membri attivi.
Scindendo la vicenda in due parti, Ferrara costruisce l'incipit quasi come una favola horror, nella quale l'orrore strisciante viene dapprima visto solo di sguincio dal piccolo Andy, come l'incubo di un bambino. La scelta del punto di vista di Andy, Marty e, in parte, di loro padre coincide con una messa in scena perlopiù in soggettiva, dove lo spettatore è chiamato ad attraversare gli ambienti e ad assistere alla follia dilagante direttamente con gli occhi dei personaggi; mentre si avvicina a questi con i soliti, magnifici, primi piani che distinguevano il cinema di Ferrara dell'epoca, talmente espressivi da rendere gli attori ancora più vivi. Nella seconda parte, il caos si espande e la lotta per la sopravvivenza contro l'omologazione diviene imperativa.
La costruzione della tensione nella prima parte è da manuale: alle prese con un genere solo sfiorato, Ferrara dimostra un'ottima dimestichezza nel creare suspanse e sopratutto nel farla esplodere all'improvviso, come nella scena in cui Andy scopre il simulacro della madre. Da antologia la fotografia del fido Bojan Bazzelli, che usa le tenebre per dipingere ogni singolo ambiente, contrastando ogni scena in modo netto ed espressivo. Persino la direzione di un duo di attori inesperti, la Anwar e Wirth, riesce a sopperire alle mancanze della sceneggiatura e a far respirare due personaggi ai quali, su carta, veniva concesso poco spazio per l'introspezione.
Dismessi i baccelli vegetali del classico di Siegel, gli ultracorpi di Ferrara sono i più viscerali mai apparsi su schermo. La fagocitazione del corpo estraneo avviene ora con tentacoli che avvinghiano la vittima, mentre in un vero e proprio utero una nuova vita viene creata. Non c'è quasi nessuna differenza, sul piano biologico, tra l'originale e la copia: anche l'invasore ha qui la dignità di un essere vivente. Tanto che nell'epilogo, la "giusta vendetta" di Andy, novella Thana qui chiamata a riscattare l'umanità tutta, si colora di una nota truce, nella quale l'orrore dello sterminio gratuito e feroce cancella ogni effettiva forma di giustizia. Il massacro operato dagli umani non è meno sconvolgente dell'omologazione aliena, facendo risaltare tutta la brutalità di cui l'uomo è capace. La contrapposizione tra creature di puro intelletto e animali civilizzati non ha così né vincitori né vinti, non finisce a causa di un finale aperto che mima quello dei due film precedente, senza purtroppo eguagliarne la carica distruttiva, ma lasciando comunque lo spettatore scosso, nella scomoda posizione di valutare tutto l'orrore al quale ha assistito: l'orrore di un mondo in preda alla cieca violenza, l'orrore di un mondo pacifico, ma privo di vita.
Elegante ed inquietante, "Body Snatchers" è un piccolo esempio di cinema commerciale che nelle mani dell'autore giusto riesce ad essere più profondo di quanto ci si potrebbe aspettare. Di certo non un capolavoro, ma una piccola gemma che merita di essere riscoperta. Sopratutto a seguito dell'infausta visione di "Invasion" (2006), ultimo e peggiore adattamento del romanzo di Finney, che grida vendetta.
mercoledì 16 settembre 2015
Cani Arrabbiati
di Mario Bava.
con: Maurice Poli, Riccardo Cucciolla, Don Backy, George Eastman, Lea Lander.
Italia (1974)
"Cani Arrabbiati" è il film più scostante nella filmografia di Bava, non solo per la curiosa vicenda produttiva che lo ha visto protagonista, quanto per temi e stile.
E' il 1973 quando il grande artista decide di mettere da parte le le trame fantastiche, la costruzione thrilling e la violenza grafica che lo resero celebre per coniare uno stile più ruvido e diretto, utile per affrontare una storia più verosimile e spiazzante, contornata da una violenza palpabile, ma mai barocca. Il risultato è un thriller tesissimo, ambientato nell'interno di un'automobile che viaggia senza meta nelle campagne laziali, dove i "mostri" sono tre rapinatori senza scrupoli e la tensione è contornata da un'atmosfera malsana. Tanto che, pur non essendo l'ultimo film da lui diretto, lo si può tranquillamente vedere come il canto del cigno della sua carriera; un epilogo feroce e privo di compromessi, nel quale sotto sotto non sarebbe sbagliato vedere una forma di ribellione contro gli stilemi di un cinema, quello del "genere" italiano, che cominciava davvero ad andargli stretto.
Riducendo la storia all'osso, Bava si concentra sui personaggi e sul loro rapporto. I tre rapinatori, i cani arrabbiati del titolo, sono ovviamente i carnefici, frutto questa volta della violenza metropolitana. Bava si rifà esplicitamente alla violenza che permea le strade della capitale dell'epoca, una violenza credibile eppure folle, che ha il volto di un ispiratissimo George Eastman, il Trentadue che si diverte a seviziare psicologicamente le sue vittime e la cui tara mentale è perfettamente trasmessa dallo sguardo spiritato del suo interprete. Una violenza che si abbatte sulla gente comune: un ordinario padre di famiglia, che ha il volto da uomo medio del compianto Riccardo Cucciolla, un bambino ed una donna, Lea Lander, ossia le vittime perfette da parte di coloro che vivono e respirano la sottomissione altrui. Proprio la donna è l'oggetto principale della cattiveria del gruppo, non solo del sessualmente deviato Trentadue, ma anche del sadico Bisturi di Don Becky, che si esalta rievocando le gioie dell'eviscerazione.
Violenza che va pari passo con la tensione, che Bava dosa sapientemente alternando vari crescendo; man mano che la fuga in auto procede, l'atmosfera, sempre più torbida, esplode in episodi di sadismo sempre più esplicito, dove il culmine viene raggiunto non nel finale, comunque memorabile, ma a metà della durata, quando i due aguzzini si divertono a costringere il personaggio della Lander ad urinarsi addosso per i loro ludibrio. Sequenza scomoda, genuinamente disturbante, figlia più che del rape & revenge americano, dell'atmosfera di disillusione che permeava la Penisola dell'epoca: non c'è scampo al male, sopratutto a quello più basilare, alla sopraffazione più compiaciuta.
L'atmosfera torbida è palpabile in ogni singola scena; la tensione non scema mai del tutto: per il 95 minuti scarsi di durata, lo spettatore è preso per il collo e forzato a viaggiare fianco a fianco ai cinque personaggi. La regia di Bava qui abbandona la sua classica plasticità per concentrarsi maggiormente sul montaggio serrato, in particolare in quello dei primi piani dei personaggi, che quasi si rivolgono allo stesso spettatore nei loro dialoghi. Il ritmo è alto grazie all'uso di inquadrature veloci e di movimenti di macchina fulminei.
E se visto in prospettiva, ci si accorge di come qui il grande maestro romano avesse già anticipato quella piega che il cinema di genere avrebbe preso nel 1985 con "Vivere e Morire a Los Angeles" e negli anni '90 con il cinema di Tarantino; un genere che si fa ancora più duro e cattivo, più sporco e disilluso e dalla violenza spiazzante: quel Pulp che tanto lustro a portato al cinema americano e che qui trova un degno antesignano.
Ma sfortunatamente, "Cani Arrabbiati" non può essere considerato come una pellicola spartiacque o influente a causa della sua funambolica vicenda produttiva.
Concluse le riprese nel tardo 1973, il produttore Roberto Loyola viene arrestato per bancarotta ed il film, ancora in fase di montaggio, sottoposto a sequestro dalla finanza. Di fatto, "Cani Arrabbiati" non ha mai visto il buio della sala, essendo stato distribuito per il mercato Home Video solo a partire dalla fine degli anni '90, per di più in due versioni distinte.
Ma, dinanzi alla potenza delle immagini evocate da Bava, è impossibile non immagine l'immane impatto che avrebbe avuto all'epoca: una pellicola sporca, trucida ma mai compiaciuta, grezza eppure raffinata, come solo il miglior cinema di genere sa(peva) essere.
EXTRA
Il limbo produttivo sul film ha trovato fine solo nei primi anni '90; ottenuti i diritti della pellicola, fu l'attrice Lea Lander a curarne una prima edizione, ribattezzata "Semaforo Rosso" e distribuita per la prima volta in Italia grazie ad una trasmissione di Sky nel 2004. Pur essendo stata disconosciuta da Lamberto Bava, che all'epoca delle riprese lavorò come aiuto regista, è questa la versione migliore e più vicina allo spirito originario del film. Nell'edizione DVD tedesca del 1999 è stato anche inserito un prologo, girato ex novo, dove la madre del bambino ne piange la scomparsa.
Meno riuscita è invece la "versione ufficiale" curata da Lamberto e Roy Bava nel 2002 e sototittolata "Kidnapped", nella quale sono state aggiunte intere sequenze con protagonista sempre la madre del bambino ed un commissario di polizia. Scene girate ex novo da Lamberto Bava che mal si integrano con il resto del girato e che anticipano troppo lo spiazzante e beffardo colpo di scena finale.
Entrambe le versioni sono reperibili sul DVD della RaroVideo
con: Maurice Poli, Riccardo Cucciolla, Don Backy, George Eastman, Lea Lander.
Italia (1974)
"Cani Arrabbiati" è il film più scostante nella filmografia di Bava, non solo per la curiosa vicenda produttiva che lo ha visto protagonista, quanto per temi e stile.
E' il 1973 quando il grande artista decide di mettere da parte le le trame fantastiche, la costruzione thrilling e la violenza grafica che lo resero celebre per coniare uno stile più ruvido e diretto, utile per affrontare una storia più verosimile e spiazzante, contornata da una violenza palpabile, ma mai barocca. Il risultato è un thriller tesissimo, ambientato nell'interno di un'automobile che viaggia senza meta nelle campagne laziali, dove i "mostri" sono tre rapinatori senza scrupoli e la tensione è contornata da un'atmosfera malsana. Tanto che, pur non essendo l'ultimo film da lui diretto, lo si può tranquillamente vedere come il canto del cigno della sua carriera; un epilogo feroce e privo di compromessi, nel quale sotto sotto non sarebbe sbagliato vedere una forma di ribellione contro gli stilemi di un cinema, quello del "genere" italiano, che cominciava davvero ad andargli stretto.
Riducendo la storia all'osso, Bava si concentra sui personaggi e sul loro rapporto. I tre rapinatori, i cani arrabbiati del titolo, sono ovviamente i carnefici, frutto questa volta della violenza metropolitana. Bava si rifà esplicitamente alla violenza che permea le strade della capitale dell'epoca, una violenza credibile eppure folle, che ha il volto di un ispiratissimo George Eastman, il Trentadue che si diverte a seviziare psicologicamente le sue vittime e la cui tara mentale è perfettamente trasmessa dallo sguardo spiritato del suo interprete. Una violenza che si abbatte sulla gente comune: un ordinario padre di famiglia, che ha il volto da uomo medio del compianto Riccardo Cucciolla, un bambino ed una donna, Lea Lander, ossia le vittime perfette da parte di coloro che vivono e respirano la sottomissione altrui. Proprio la donna è l'oggetto principale della cattiveria del gruppo, non solo del sessualmente deviato Trentadue, ma anche del sadico Bisturi di Don Becky, che si esalta rievocando le gioie dell'eviscerazione.
Violenza che va pari passo con la tensione, che Bava dosa sapientemente alternando vari crescendo; man mano che la fuga in auto procede, l'atmosfera, sempre più torbida, esplode in episodi di sadismo sempre più esplicito, dove il culmine viene raggiunto non nel finale, comunque memorabile, ma a metà della durata, quando i due aguzzini si divertono a costringere il personaggio della Lander ad urinarsi addosso per i loro ludibrio. Sequenza scomoda, genuinamente disturbante, figlia più che del rape & revenge americano, dell'atmosfera di disillusione che permeava la Penisola dell'epoca: non c'è scampo al male, sopratutto a quello più basilare, alla sopraffazione più compiaciuta.
L'atmosfera torbida è palpabile in ogni singola scena; la tensione non scema mai del tutto: per il 95 minuti scarsi di durata, lo spettatore è preso per il collo e forzato a viaggiare fianco a fianco ai cinque personaggi. La regia di Bava qui abbandona la sua classica plasticità per concentrarsi maggiormente sul montaggio serrato, in particolare in quello dei primi piani dei personaggi, che quasi si rivolgono allo stesso spettatore nei loro dialoghi. Il ritmo è alto grazie all'uso di inquadrature veloci e di movimenti di macchina fulminei.
E se visto in prospettiva, ci si accorge di come qui il grande maestro romano avesse già anticipato quella piega che il cinema di genere avrebbe preso nel 1985 con "Vivere e Morire a Los Angeles" e negli anni '90 con il cinema di Tarantino; un genere che si fa ancora più duro e cattivo, più sporco e disilluso e dalla violenza spiazzante: quel Pulp che tanto lustro a portato al cinema americano e che qui trova un degno antesignano.
Ma sfortunatamente, "Cani Arrabbiati" non può essere considerato come una pellicola spartiacque o influente a causa della sua funambolica vicenda produttiva.
Concluse le riprese nel tardo 1973, il produttore Roberto Loyola viene arrestato per bancarotta ed il film, ancora in fase di montaggio, sottoposto a sequestro dalla finanza. Di fatto, "Cani Arrabbiati" non ha mai visto il buio della sala, essendo stato distribuito per il mercato Home Video solo a partire dalla fine degli anni '90, per di più in due versioni distinte.
Ma, dinanzi alla potenza delle immagini evocate da Bava, è impossibile non immagine l'immane impatto che avrebbe avuto all'epoca: una pellicola sporca, trucida ma mai compiaciuta, grezza eppure raffinata, come solo il miglior cinema di genere sa(peva) essere.
EXTRA
Il limbo produttivo sul film ha trovato fine solo nei primi anni '90; ottenuti i diritti della pellicola, fu l'attrice Lea Lander a curarne una prima edizione, ribattezzata "Semaforo Rosso" e distribuita per la prima volta in Italia grazie ad una trasmissione di Sky nel 2004. Pur essendo stata disconosciuta da Lamberto Bava, che all'epoca delle riprese lavorò come aiuto regista, è questa la versione migliore e più vicina allo spirito originario del film. Nell'edizione DVD tedesca del 1999 è stato anche inserito un prologo, girato ex novo, dove la madre del bambino ne piange la scomparsa.
Meno riuscita è invece la "versione ufficiale" curata da Lamberto e Roy Bava nel 2002 e sototittolata "Kidnapped", nella quale sono state aggiunte intere sequenze con protagonista sempre la madre del bambino ed un commissario di polizia. Scene girate ex novo da Lamberto Bava che mal si integrano con il resto del girato e che anticipano troppo lo spiazzante e beffardo colpo di scena finale.
Entrambe le versioni sono reperibili sul DVD della RaroVideo
mercoledì 9 settembre 2015
Il Ritorno dello Jedi
 Return of the Jedi
Return of the Jedidi Richard Marquand.
con: Mark Hamil, Harrison Ford, Carrie Fisher, Billy Dee Williams, David Prowse, James Earl Jones, Ian McDiarmid, Sebastian Shaw, Peter Mayhew, Anthony Daniels, Kenny Baker, Warvick Davis, Frank Oz.
Avventura/Fantastico
Usa (1983)
E' abitudine consolidata per tutti i fans di "Guerre Stellari" affermare come la loro saga preferita si sia distrutta a partire dal '99, con "La Minaccia Fantasma" e relativi seguiti, colpevoli di aver trasformato un pezzo di cultura popolare in un calderone di effetti speciali senz'anima, creato con il solo scopo di macinare soldi. Ben farebbero a riguardarsi "Il Ritorno dello Jedi" con occhio critico, per notare come tutti i difetti della "nuova trilogia" erano già tutti presenti in embrione nel 1983, seppur accompagnati da qualche sparuto pregio.
La produzione del terzo e temporaneamente ultimo capitolo della saga comincia nel 1981; Lucas vuole che a dirigere il film sia l'amico Steven Spielberg, ma la militanza di quest'ultimo nel sindacato dei registi, ostile a Lucas sin del '77 a causa della mancanza di titoli di testa nel primo "Guerre Stellari", gli impedisce di prendere parte al progetto.
Lucas decide così di approfittarne e cambiare strategia per il suo gran finale: complice anche l'invidia, esternata da molti suoi collaboratori, per il lavoro svolto da Irvin Kershner sul set di "L'Impero Colpisce Ancora", inizia la ricerca spasmodica di un regista-pupazzo da manipolare per avere il controllo totale della sua opera; l'interesse del produttore-padrone si sposta così su due giovani cineasti che non hanno nulla a che vedere con il cinema commerciale, ossia David Lynch e David Cronenberg, che Lucas spera di tirare a bordo e plagiare a causa della loro inesperienza, per fortuna invano, proprio come il malvagio Imperatore del suo film. I due, in seguito, non negheranno mai l'ostilità verso l'autore e la sua creatura, dovuta alla sua mentalità di deus ex machina privo di ispirazione e a caccia di facili guadagni. Affrancatisi i due principali candidati, a spuntarla è così il gallese Richard Marquand, regista per lo più di serie e film per la televisione, ma all'epoca fresco del successo de "La Cruna dell'Ago" e che dopo l'exploit lucasiano avrebbe diretto solo pochi altri film per spegnersi prematuramente nel 1987.
Per assicurarsi il controllo completo, Lucas arriva sinanche a licenziare il produttore Gary Kurtz, il cui apporto fu essenziale per la creazione della saga; il "siluramento" è dovuto a differenze di vedute: Kurtz voleva fare le cose in grande, ma a Lucas interessavano solo gli effetti speciali, poichè, come ammise esplicitamente, al pubblico non interessano trame o personaggi, ma solo gli effetti.
Genesi produttiva che si riverbera totalmente sul prodotto finito: un giocattolone piatto, sgangherato e a tratti sciatto, che ha l'unico merito di intessere un singolare confronto tra l'eroe e la sua nemesi e nulla più.
La divisione in tre parti distinte non aiuta alla riuscita; l'intero primo atto è una sottotrama sul salvataggio di Han Solo, dopo la quale il film ricomincia da capo con il vero incipit per l'attacco contro la Nuova Morte Nera, riarrangiamento della vecchia traccia narrativa del primo film che fa diventare subito la storia stantia; l'ultimo atto, d'altro canto, è diviso a sua volta in tre sottotrame con tre battaglie: una nello spazio, una a terra ed un duello a tre, giusto per non scontentare nessuno degli aficionados.
La prima parte è solo in apparenza la più ridicola: un piano di salvataggio inutilmente macchinoso che culmina ugualmente in una battaglia furiosa, prima della quale la noia fa capolino sovente; il "palazzo delle torture" di Jabba altro non è se non un escamotage per piazzare su schermo il maggior numero possibile di animatronic e tizi in costume, mentre lo scontro sul vascello è talmente rocambolesco che sembra pensato più per un film di Indiana Jones; e tra una comparsa fucilata, le forme di una compiaciuta Carrie Fisher ed il vermone antropomorfo strozzato in una sequenza sorprendentemente violenta, Lucas decide di tagliare corto la storia del cacciatore di taglie Boba Fett con una delle morti più involontariamente ironiche viste ad Hollywood.
Il secondo atto è anche più ridicolo e soporifero; la scoperta della parentela tra Luke e Leia è buttata lì giusto per creare un nuovo colpo di scena spaccamascella e fa calare una cappa di cattivo gusto sui due film precedenti, dove la tensione sessuale tra i due era palpabile, a riprova di come il buon Lucas non avesse in mente la storia finchè non l'ha messa nero su bianco.
L'assalto ad Endor con la corsa sulle speeder bike è spettacolare, ma la mancanza di pathos e vera tensione tra i personaggi la rende fredda ed inerte.
L'inclusione degli Ewoks, i pestiferi orsacchiotti tribali, rende esplicita la volontà di Lucas di creare più merchandising possibile e sdogana definitivamente il ridicolo nella serie: non si riesce a credere ad un Impero del Male ipertecnologico guidato da uno stregone, le cui armi sono in grado di disintegrare interi pianeti, messo in scacco da dei peluche armati di sassi e bastoni
La tripla battaglia finale, tra esplosioni e effetti speciali roboanti, non vale quelle dei due film precedenti. Marquand non sa gestire i tempi del cinema d'azione: la battaglia su Endor è troppo lunga e priva di mordente, quella nello spazio troppo veloce; e arrivati al terzo capitolo della saga, si sa che nessuno dei personaggi può morire, visto il favore dei fans, ma il loro ruolo è comunque ridimensionato nello scheletrico schema degli eventi; per cui Han Solo è perennemente sullo sfondo a fare battute e i due droidi seguono in guerra i loro compagni pur non avendo alcuna capacità bellica, restando anch'essi relegati a pura decorazione.
Più interessante è invece la parte con Luke, Darth Vader e l'Imperatore, il cui confronto, pur se troppo lungo e ridondante, riesce ad incantare.
L'intento principale di Luke è quello di redimere il padre, salvarlo dalla tenebra che lo cinge; per farlo usa l'arma della comprensione, lasciandosi arrestare; l'Imperatore, d'altro canto, vuole plagiare il ragazzo, trasformarlo in un suo burattino; l'Imperatore è il Male supremo, Luke il Bene, Vader l'ago della bilancia; la violenza viene bandita: come Yoda ne "L'Impero Colpisce Ancora", Luke è ora cosciente di come l'abbandono alle emozioni più distruttive sia nocivo; quando sguaina la spada, stuzzicato dal padre, il duello che segue è furioso e distruttivo, ma culmina nella coscienza della sua inutilità e nel rifiuto dell'arma; non c'è volontà marziale nell'incontro, ma solo lo scontro tra coscienze che porta alla redenzione finale di Vader. Una catarsi anticlimatica che Marquand gioca tutta sui primi piani degli attori, anche a causa della natura televisiva del suo stile, riuscendo a cogliere perfettamente le sfumature dei personaggi nonostante una recitazione tronfia.
Il sogno di Lucas si conclude così in una nota stonata: un terzo capitolo blando e poco emozionante che testimonia il suo definitivo abbandono di ogni velleità artistica. Paradossalmente, resta pur sempre un capolavoro della cinematografia moderna se paragonato a quanto farà in seguito.
EXTRA
"Il Ritorno dello Jedi" è l'unico film dell'intera serie ad essere stato soggetto ad una forma di "autocensura" da parte del suo autore.
Inizialmente Lucas aveva intenzione di concludere la saga in modo duro e drammatico, come una tragedia cosmica: a metà film Darth Vader sarebbe morto e Luke, passato al lato oscuro, ne avrebbe ereditato il titolo; l'Imperatore avrebbe dovuto essere sconfitto da Leia, il cui amore avrebbe redento Luke, riportandolo tra le fila dei buoni.
Scenario drammatico ed incredibilmente interessante, che Lucas ha cestinato in favore di botti ed orsachiotti. A sua discolpa va detto che in una delle versioni definitive dello script, su Endor sarebbero dovuti esserci gli Wookies; ma a poche settimane dall'inizio delle riprese, Lucas si è accorto di come un orsacchitto sia più vendibile di un orso adulto ed ha inserito la tribù di nani pelosi nel film, alla faccia della credibilità.
Poco prima dell'uscita ha infine cambiato anche il titolo del film, che in origine avrebbe dovuto essere "Revenge of the Jedi".
Tra i ritocchi fatti al film nelle sue varie riedizioni:
Il palazzo di Jabba era stato concepito come una bizzara alcova di morte e depravazione; ma Lucas ad un certo punto ci ha ripensato e ha deciso di renderlo più allegro:
L'inserto canoro è stato allungato a partire dall'edizione del 1997; il "karaoke spaziale" è ora una sequenza che sembra uscita da un trip in acido di Walt Disney.
Nell'edizione originale, il Sarlaak era una sorta di Cariddi del deserto; in quella del 1997 è invece una stramba creatura con becco e tentacoli.
A partire dall'edizione Blu-Ray del 2010, R2-D2 ha guadagnato tutta una serie di ammennicoli in GCI che gli escono dal corpo; il perchè non si sa.
Nella versione originale, Darth Vader sfoggia delle folte sopracciglia nell'iconica scena in cui viene smascherato; le ghiandole pilifere gli saranno rimosse digitalmente a partire dal 1997.
La modifica più stramba, contestata e priva di senso: nell'ultima scena il fantasma di Anakin Skywalker non ha più le sembianze dell'uomo dietro la maschera, interpretato da Sebastian Shaw, ma quelle del giovane Anakin della "nuova trilogia", interpretato da Hayden Christiansen. Il perchè di tale cambiamento è un mistero, fatto sta che, come al solito, non funziona, poichè non si capisce come faccia Luke a riconoscerlo; e sopratutto perchè sfoggi un'espressione da maniaco sessuale eccitato.
"Il Ritorno dello Jedi" è anche l'unico film della serie del quale molto del materiale migliore è rimasto sul pavimento della sala di montaggio; alcune scene, molto riuscite, sono state eliminate o rigirate per motivi ignoti.
Oltre alla spettacolare fuga nella tempesta di sabbia che doveva chiudere il primo atto, la scena più interessante è quella in cui Luke viene tentato a passare al lato oscuro mentre è nel deserto, come un novello profeta: per la prima volta la moralità del personaggio viene questionata, aggiungendovi carattere. Forse Lucas temeva che personaggi troppo sfaccettati avrebbero danneggiato le vendite dei pupazzetti.
Per assicurarsi il controllo completo, Lucas arriva sinanche a licenziare il produttore Gary Kurtz, il cui apporto fu essenziale per la creazione della saga; il "siluramento" è dovuto a differenze di vedute: Kurtz voleva fare le cose in grande, ma a Lucas interessavano solo gli effetti speciali, poichè, come ammise esplicitamente, al pubblico non interessano trame o personaggi, ma solo gli effetti.
Genesi produttiva che si riverbera totalmente sul prodotto finito: un giocattolone piatto, sgangherato e a tratti sciatto, che ha l'unico merito di intessere un singolare confronto tra l'eroe e la sua nemesi e nulla più.
La divisione in tre parti distinte non aiuta alla riuscita; l'intero primo atto è una sottotrama sul salvataggio di Han Solo, dopo la quale il film ricomincia da capo con il vero incipit per l'attacco contro la Nuova Morte Nera, riarrangiamento della vecchia traccia narrativa del primo film che fa diventare subito la storia stantia; l'ultimo atto, d'altro canto, è diviso a sua volta in tre sottotrame con tre battaglie: una nello spazio, una a terra ed un duello a tre, giusto per non scontentare nessuno degli aficionados.
La prima parte è solo in apparenza la più ridicola: un piano di salvataggio inutilmente macchinoso che culmina ugualmente in una battaglia furiosa, prima della quale la noia fa capolino sovente; il "palazzo delle torture" di Jabba altro non è se non un escamotage per piazzare su schermo il maggior numero possibile di animatronic e tizi in costume, mentre lo scontro sul vascello è talmente rocambolesco che sembra pensato più per un film di Indiana Jones; e tra una comparsa fucilata, le forme di una compiaciuta Carrie Fisher ed il vermone antropomorfo strozzato in una sequenza sorprendentemente violenta, Lucas decide di tagliare corto la storia del cacciatore di taglie Boba Fett con una delle morti più involontariamente ironiche viste ad Hollywood.
Il secondo atto è anche più ridicolo e soporifero; la scoperta della parentela tra Luke e Leia è buttata lì giusto per creare un nuovo colpo di scena spaccamascella e fa calare una cappa di cattivo gusto sui due film precedenti, dove la tensione sessuale tra i due era palpabile, a riprova di come il buon Lucas non avesse in mente la storia finchè non l'ha messa nero su bianco.
L'assalto ad Endor con la corsa sulle speeder bike è spettacolare, ma la mancanza di pathos e vera tensione tra i personaggi la rende fredda ed inerte.
L'inclusione degli Ewoks, i pestiferi orsacchiotti tribali, rende esplicita la volontà di Lucas di creare più merchandising possibile e sdogana definitivamente il ridicolo nella serie: non si riesce a credere ad un Impero del Male ipertecnologico guidato da uno stregone, le cui armi sono in grado di disintegrare interi pianeti, messo in scacco da dei peluche armati di sassi e bastoni
La tripla battaglia finale, tra esplosioni e effetti speciali roboanti, non vale quelle dei due film precedenti. Marquand non sa gestire i tempi del cinema d'azione: la battaglia su Endor è troppo lunga e priva di mordente, quella nello spazio troppo veloce; e arrivati al terzo capitolo della saga, si sa che nessuno dei personaggi può morire, visto il favore dei fans, ma il loro ruolo è comunque ridimensionato nello scheletrico schema degli eventi; per cui Han Solo è perennemente sullo sfondo a fare battute e i due droidi seguono in guerra i loro compagni pur non avendo alcuna capacità bellica, restando anch'essi relegati a pura decorazione.
Più interessante è invece la parte con Luke, Darth Vader e l'Imperatore, il cui confronto, pur se troppo lungo e ridondante, riesce ad incantare.
L'intento principale di Luke è quello di redimere il padre, salvarlo dalla tenebra che lo cinge; per farlo usa l'arma della comprensione, lasciandosi arrestare; l'Imperatore, d'altro canto, vuole plagiare il ragazzo, trasformarlo in un suo burattino; l'Imperatore è il Male supremo, Luke il Bene, Vader l'ago della bilancia; la violenza viene bandita: come Yoda ne "L'Impero Colpisce Ancora", Luke è ora cosciente di come l'abbandono alle emozioni più distruttive sia nocivo; quando sguaina la spada, stuzzicato dal padre, il duello che segue è furioso e distruttivo, ma culmina nella coscienza della sua inutilità e nel rifiuto dell'arma; non c'è volontà marziale nell'incontro, ma solo lo scontro tra coscienze che porta alla redenzione finale di Vader. Una catarsi anticlimatica che Marquand gioca tutta sui primi piani degli attori, anche a causa della natura televisiva del suo stile, riuscendo a cogliere perfettamente le sfumature dei personaggi nonostante una recitazione tronfia.
Il sogno di Lucas si conclude così in una nota stonata: un terzo capitolo blando e poco emozionante che testimonia il suo definitivo abbandono di ogni velleità artistica. Paradossalmente, resta pur sempre un capolavoro della cinematografia moderna se paragonato a quanto farà in seguito.
EXTRA
"Il Ritorno dello Jedi" è l'unico film dell'intera serie ad essere stato soggetto ad una forma di "autocensura" da parte del suo autore.
Inizialmente Lucas aveva intenzione di concludere la saga in modo duro e drammatico, come una tragedia cosmica: a metà film Darth Vader sarebbe morto e Luke, passato al lato oscuro, ne avrebbe ereditato il titolo; l'Imperatore avrebbe dovuto essere sconfitto da Leia, il cui amore avrebbe redento Luke, riportandolo tra le fila dei buoni.
Scenario drammatico ed incredibilmente interessante, che Lucas ha cestinato in favore di botti ed orsachiotti. A sua discolpa va detto che in una delle versioni definitive dello script, su Endor sarebbero dovuti esserci gli Wookies; ma a poche settimane dall'inizio delle riprese, Lucas si è accorto di come un orsacchitto sia più vendibile di un orso adulto ed ha inserito la tribù di nani pelosi nel film, alla faccia della credibilità.
Poco prima dell'uscita ha infine cambiato anche il titolo del film, che in origine avrebbe dovuto essere "Revenge of the Jedi".
Tra i ritocchi fatti al film nelle sue varie riedizioni:
Il palazzo di Jabba era stato concepito come una bizzara alcova di morte e depravazione; ma Lucas ad un certo punto ci ha ripensato e ha deciso di renderlo più allegro:
L'inserto canoro è stato allungato a partire dall'edizione del 1997; il "karaoke spaziale" è ora una sequenza che sembra uscita da un trip in acido di Walt Disney.
Nell'edizione originale, il Sarlaak era una sorta di Cariddi del deserto; in quella del 1997 è invece una stramba creatura con becco e tentacoli.
A partire dall'edizione Blu-Ray del 2010, R2-D2 ha guadagnato tutta una serie di ammennicoli in GCI che gli escono dal corpo; il perchè non si sa.
Nella versione originale, Darth Vader sfoggia delle folte sopracciglia nell'iconica scena in cui viene smascherato; le ghiandole pilifere gli saranno rimosse digitalmente a partire dal 1997.
La modifica più stramba, contestata e priva di senso: nell'ultima scena il fantasma di Anakin Skywalker non ha più le sembianze dell'uomo dietro la maschera, interpretato da Sebastian Shaw, ma quelle del giovane Anakin della "nuova trilogia", interpretato da Hayden Christiansen. Il perchè di tale cambiamento è un mistero, fatto sta che, come al solito, non funziona, poichè non si capisce come faccia Luke a riconoscerlo; e sopratutto perchè sfoggi un'espressione da maniaco sessuale eccitato.
"Il Ritorno dello Jedi" è anche l'unico film della serie del quale molto del materiale migliore è rimasto sul pavimento della sala di montaggio; alcune scene, molto riuscite, sono state eliminate o rigirate per motivi ignoti.
Oltre alla spettacolare fuga nella tempesta di sabbia che doveva chiudere il primo atto, la scena più interessante è quella in cui Luke viene tentato a passare al lato oscuro mentre è nel deserto, come un novello profeta: per la prima volta la moralità del personaggio viene questionata, aggiungendovi carattere. Forse Lucas temeva che personaggi troppo sfaccettati avrebbero danneggiato le vendite dei pupazzetti.
venerdì 4 settembre 2015
The Wicker Man
 di Robin Hardy.
di Robin Hardy.con: Edward Woodward, Christopher Lee, Britt Ekland, Diane Cilento, Ingrid Pitt, Aubrey Morris.
Inghilterra (1973)
---CONTIENE SPOILER---
Il semplice status di "pellicola di culto" non rende giustizia ad un film come "The Wicker Man"; l'affetto dei fan e le celebrazioni che ogni anno si tengono in Gran Bretagna ed in America per ricordarne i fasti, sulla falsariga di quelle mostrate nel film stesso, non aiutano certo a comprendere il valore immenso del lavoro dei suoi autori, né a rievocarne la travagliata storia distributiva.
Se non fosse per "Cannibal Holocaust" (1980), si potrebbe tranquillamente etichettare il film di Robin Hardy come il più censurato di sempre; ma se nel caso del film di Deodato la censura era intervenuta a causa delle immagini forti e provocatorie, per "The Wicker Man" il discorso è più complesso e poggia sulla secolare avversione che l'Inghilterra conservatrice ha per il sesso. Era impensabile, all'epoca, non sforbiciare i fotogrammi di un film che portava la nudità in scena senza filtri, ma anche senza malizia; né era ammissibile un film che scavasse sulle radici pagane e libertine di quella società all'epoca (ed in parte tutt'oggi) ipocritamente perbenista.
Ma "The Wicker Man" non è pura rievocazione di un passato scomodo, quanto la messa in scena di uno scontro totale tra le credenze pagane ed il cattolicesimo; scontro culturale, prima ancora che religioso, tutt'oggi affascinante.
La genesi del film è stramba e spiazzante quanto la storia che racconta; sarebbe facile pensare, di fronte alle forti immagini, come "The Wicker Man" fosse il frutto di menti avanguardiste e votate alla provocazione; ben più prosaica è la realtà: il progetto è partito grazie alla collaborazione tra il produttore Peter Snell e il drammaturgo Anthony Shaffer, all'epoca fresco del successo di "Sleuth" (1972); Snell voleva creare un film per rilanciare la carriera di Christopher Lee, arenatasi a seguito del declino delle produzioni Hammer, mentre Shaffer rimase affascinato dalla lettura del romanzo "Ritual" di David Pinner, vero e proprio palinsesto per la sceneggiatura, sebbene non accreditato. Sempre Shaffer decise di dare un taglio oltranzista allo script come reazione alla riscoperta dei rituali celtici da parte della controcultura inglese e mitteleuropea: orde di hippie, che di lì a poco sarebbero scomparsi a seguito del fallimento della grande comune di San Francisco, si dedicavano ai rituali della fecondità pre-cristiani, in opposizione alla severa cultura cristiana che predicava l'astensione e il martirio delle carni.
Ben si potrebbe pensare, guardando le ultime dichiarazioni di Shaffer prima della sua scomparsa, ad una sua simpatia verso la cultura celtica e druidica; ma non ci sarebbe nulla di più sbagliato: "The Wicker Man" bolla il passato "allegro" delle religioni arcaiche come una barbarie oscurantista; e, paradossalmente, la religione cristiana, pur non esaltata, diviene nel film portatrice di razionalità, a dimostrazione di come i vecchi rituali non siano altro che pura superstizione.
E' merito infine del regista Robin Hardy, di fatto poco prolifico e forse finanche poco talentuoso, se la tensione regge e il mondo ricreato da Shaffer affascina tutt'oggi.
Portatore dei dettami del Cattolicesimo è il poliziotto Howie (Woodward), introdotto come un buon cristiano che legge i passi del Nuovo Testamento con fervore; chiamato ad investigare sulla scomparsa della piccola Rowan Morrison, Howie si ritrova sull'isola di Summerisle in un mondo altro, nel quale sono stati reintrodotti i culti elementali; in un indagine simile a quella dell'agente Cooper in "Twin Peaks", si ritroverà circondato da strani individui, tra i quali l'eccentrico Lord Summerisle (Lee), in un crescendo di follia e fanatismo.
L'arrivo a Summerisle, contrariamente a quanto ci si potrebbe aspettare, spiazza per l'atmosfera viva e gioviale; i "nuovi barbari" non vengono descritti come una popolazione inselvatichita, ma come allegri paesani che celebrano la vitalità con canzoni armoniose; l'avvento della primavera e il risveglio dei sensi hanno la forma delle canzoni di Paul Giovanni, sulle quali Hardy costruisce intere sequenze, come in musical; le melodie dolci e i testi sottilmente sconci rievocano il rapporto tra gli isolani e il corpo, mentre lo spettatore non può che sentirsi ammaliato dalla beltà di luoghi e situazioni; a differenza dell'insofferente protagonista, che si vede subito spiazzato dall'apertura mentale inusitata che vi trova.
Lo scontro tra le due culture cattolica e quella pagana è totale: il culto antimondano cristiano non può tollerare la sublimazione della nudità o l'esaltazione del corpo; così come i rituali orgiastici e vitali del paganesimo non concepiscono la castrazione dell'individuo o, men che meno, le pratiche della continenza.
Dinanzi allo spettacolo dell'accoppiamento pubblico, il cristiano non può che essere spiazzato; al richiamo della carne, sublimato nella magnifica sequenza della seduzione da parte di una splendida Britt Ekland, il buon cristiano deve resistere e non cedere in tentazione; poiché corpo e spirito sono entità separate ed inconciliabili, la sensualità è nemica della beatitudine e della salvezza. D'altro canto, una religione fortemente attaccata alla civiltà contadina e al ciclo stagionale non può che venerare la fecondità e l'atto del coito, essenziale non solo per la perpetrazione della specie, quanto anche solo per la semplice sussistenza.
Howie è così un corpo estraneo chiamato a confrontarsi con un nuovo (e al contempo antico) modo di concepire il rapporto con il corpo; nei dialoghi, affiatati ed affilati, con Lord Summerisle e l'insegnate Miss Rose (Diane Cilento), la sua concezione a-sessuata della religiosità viene costantemente messa in discussione, sino a farlo risultare antiquato, come un mormone evirato dinanzi ad una ritrovata gioia spirituale che passa attraverso la carne.
La riesumazione del culto è opera di un antenato di Lord Summerisle, un positivista che nel XIX secolo tentò di importare colture fruttifere sulla sterile isola e decise di bandire il Cristianesimo non per ragioni prettamente spirituali, ma per meglio sfruttare la mano d'opera locale: il contadino, chiamato a lavorare duramente per rendere fertile l'isola, trovava appagamento totale nella gioia del sesso, usato come strumento per venerare gli dei; il ritorno al culto delle origini ha così sul piano narrativo una valenza simile a quella reale: la riscoperta del corpo come semplice forma di appagamento travestita da rituale. Con il corso del tempo, tuttavia, la religione si è sedimentata sino a diventare pratica totale, con tutte le relative conseguenze.
Lord Summerisle diviene l'incarnazione di una ritrovata sensibilità verso la natura, esordendo con uno monologo recitato da un ispiratissimo Lee sulla gioia del regredire allo stato animale, dove non bisogna inginocchiarsi dinanzi a nessuno. Culto naturale che trova nell'accoppiamento una fase rituale essenziale, al punto che il personaggio entra in scena scortando il giovane McGregor dalla Willow della Ekland, incaricata di iniziarlo al sesso.
Ancora più importante è il dialogo con Howie dinanzi al rituale del fuoco, dove l'accoppiamento con la divinità fa scorgere un inquietante parallelo con i dogmi cristiani, a sottolineare la comunanza ritualistica e misterica tra culti.
Man mano che la ricerca di Howie procede, l'isola si disvela: da luogo pacifico ed idilliaco si colora di una luce sinistra, di un'atmosfera scomoda; il culto campestre porta con sé tutte le antiche credenze, che rifuggono dalle conquiste illuminate che il Cristianesimo, pur con noti ed inescusabili limiti, ha fatto filtrare nella società occidentale; il rimedio della rana per il mal di gola viene a simboleggiare una cultura arretrata e superstiziosa, del tutto fuori luogo nel XX secolo, residuato di un passato antiquato. Mentre già l'incontro con Miss Rose fa presagire l'ottusità del popolo isolano, incapace di concepire la resurrezione del corpo poiché avulsa dal naturale ciclo di morte e rinascita proprio della natura.
Il paganesimo di impronta celtica si rivela così come un culto prettamente materiale, volto a santificare i singoli gesti insiti nel lavoro per dar loro una dignità fittizia, piuttosto che ad interrogarsi sugli effettivi misteri della vita e del mondo. Una religione arcaica, vecchia, del tutto scevra dalla effettiva dimensione spirituale; un culto totalmente superstizioso, nel quale la divinità viene temuta; e per questo, violento e realmente oscurantista.
Finito il gioco nel quale l'incauto poliziotto è stato attirato, il culto pagano rivela tutta la sua carica ottusa e distruttiva: il sacrificio al dio del sole di un essere umano nella cerimonia dell' "uomo di vimini", l'effigia umana nella quale i sacrificati sono rinchiusi per essere consacrati ad una morte rituale. Il cristiano diviene così ineluttabilmente il portatore della ragione, non solo di un culto che ha superato la barbarie del sacrificio o della paura del dio, ma anche di una religione che non ammette vere superstizioni; l'atto di conformare la coltura isolana a quella della terraferma è contro natura, ma il culto della natura non riesce ad ammettere il suo errore, solo ad interpretare il fallimento delle ultime messi come un capriccio della divinità; l'incapacità di concepire il ciclo naturale come un'essenza priva di volontà porta alla paura e alla venerazione incondizionata, vera e propria sottomissione ad un dio più crudele di quello cristiano: l'ignoranza.
Il paradosso è lampante: l'emancipazione da una religione notoriamente repressiva e contraria ad ogni forma di scientificità non porta automaticamente alla scoperta di valori positivi, quanto alla regressione ad uno stato selvaggio, più pericoloso e distruttivo della castrazione dei sensi.
La disperazione e la paura di una follia collettiva vengono incardinatati in quell'ultima, agghiacciante sequenza, nella quale la perdita di ogni ragione in favore della venerazione incondizionata si fa puro e genuino orrore.
EXTRA
I guai del film cominciarono con il cambio di direzione alla Thorn EMI Screen, depositaria dei diritti di distribuzione nel Regno Unito. Il nuovo esecutivo trovava l'operato di Shaffer e Hardy orrendo e tagliò circa 10 minuti dalla versione integrale di circa 100, andati perduti a seguito delle "pulizie" nei magazzini della società. Successivamente, la censura nazionale e la distribuzione americana hanno tagliato altri 20, eliminando tra l'altro la splendida sequenza introduttiva di Lord Summerisle. Uscito nei due mercati nel tardo 1973, "The Wicker Man" si rivelò un cocente flop. Ma grazie al passaparola, al successo nei festival internazionali e alle proiezioni di mezzanotte, venne riscoperto da un numero crescente di spettatori sino a divenire il cult più amato e ricercato dell'epoca.
A partire dal 2000 è possibile reperire in DVD un'edizione "director's cut" che riassembla parte del girato scartato. Quest'anno, inoltre, Studio Canal ha distribuito un'edizione Blu-Ray restaurata e rimontata da Hardy, più corta però della precedente director's cut.
Se l'idea di fare un remake di "The Wicker Man" appare strampalata e ridicola, è perché lo è: oggi come oggi i culti pagani gaelici sono nuovamente relegati al puro folkrore, mentre al contempo il conservatorismo cristiano-cattolico ha perso la sua presa sulla società occidentale. Questo non ha impedito a Neil LaBute e Nicolas Cage di confezione una nuova versione di "The Wicker Man" nel 2006, la quale, nella più pura tradizione dei remake ottusi made in Hollywood, cambia personaggi, ambientazioni e tematiche, aggiungendo però dosi da rinoceronte di ridicolo involontario.
Da antologia del trash la sequenza delle api, divenuta un vero e proprio tormentone su Youtube ed inizialmente tagliata nella theatrical cut per motivi facilmente intuibili:
Di peggio è riuscito a fare solo lo stesso Robin Hardy con "The Wicker Tree":
Concepito inizialmente come una continuazione di "The Wicker Man", "The Wicker Tree" è divenuto un suo seguito "spirituale" in seguito all'impossibilità di Christopher Lee di riprendere il suo ruolo di Lord Summerisle, dovuta ad un brutto incidente accorsogli sul set di "Resident" (2011). Dall'originale ritorna il tema dello scontro tra cristianesimo e paganesimo, ma la scrittura di Hardy è fiacca e superficiale e gli scarsi valori produttivi rendono il prodotto finale inguardabile.
Iscriviti a:
Post (Atom)