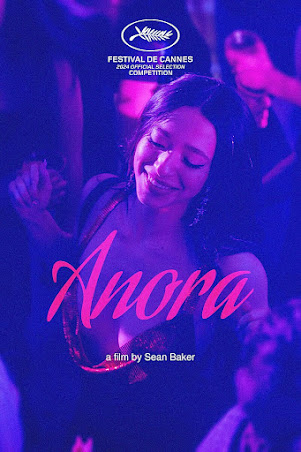con: Anthony Mackie, Harrison Ford, Giancarlo Esposito, Tim Blake Nelson, Danny Ramirez, Shira Haas, Xosha Roquermore, Carl Lumbly.
Azione/Thriller
Usa 2025
Ricapitoliamo tutta la storia produttiva di "Captain America: Brave New World".
La produzione inizia ufficialmente a metà del 2021, praticamente subito dopo la pubblicazione dell'episodio finale di The Falcon and the Winter Soldier su Disney+, sotto il titolo di "Captain America: New World Order".
A riprese completate, il test-screening è un disastro, con il pubblico che lo definisce come uno dei peggiori exploit dello MCU. Una prima sessione di riprese aggiuntive per "aggiustare" il prodotto entra quindi subito in produzione, ma al secondo test-screening il risultato non è migliore e nel frattempo il film cambia anche titolo in "Brave New World", con il preciso scopo di non stuzzicare i cospirazionisti perdigiorno. Arriva dunque una terza sessione di riprese, a conclusione della quale viene anche rivelato il primo teaser del film e fissata la data di uscita al 14 Febbraio 2025, circa quattro anni dopo l'inizio della produzione. Nel mentre, un'ulteriore sessione di riprese viene effettuata per cercare di creare un prodotto con un minimo di coerenza.
Una storia produttiva che ricorda quella di Ant-Man, il quale fu scritto in un modo da Edgar Wright, girato in un altro da Peyton Reed dopo il suo licenziamento e montato in un terzo per cercare di rendere il tutto più fluido. Ma se in quel piccolo exploit le tre visioni bene o male riuscivano a mescolarsi, qui la sensazione di guardare un qualcosa di monco è evidente.
Cosa sia rimasto del progetto originario non è chiaro. Alcune voci di corridoio parlano della presenza iniziale di She-Hulk come villain aggiuntiva al fianco del Leader, eliminata sia per il flop della serie omonima, sia per l'effetto ridicolo del suo ruolo nella storia: pare che l'eroina avrebbe dovuto cambiare bandiera solo per, letteralmente, attirare l'attenzione del cugino. Modifica praticamente confermata è invece quella che ha visto i cattivi della Serpent Society, storico gruppo di avversari di Capitan America presenti anche nel film finito; nei piani originari avrebbero dovuto avere dei superpoteri, ma in fase di post-produzione questi sono stati eliminati e il gruppo è stato ridotto ad un misero drappello di anonimi mercenari.
Destino simile è toccato al personaggio di Ruth Bath-Seraph, supereroina di origine israeliana che avrebbe dovuto avere un ruolo di spicco negli eventi, ma che alla fine è poco più di una spalla, ridimensionamento seguito probabilmente alla scoppio della tragedia di Gaza. Quanto al coinvolgimento di Giancarlo Esposito nei panni del villain Sidewinder, leader dei Serpent, alla fine ciò che resta è solo un tizio armato di fucile che compare di tanto in tanto.
E in tutto questo, non si capisce in quale parte della linea temporale dello MCU questa vicenda sia ambientata, visto che non si fa menzione degli eventi di Secret Wars o di The Marvels, forse prima o forse dopo questi e tutti hanno dimenticato il vecchio presidente e la sua guerra agli alieni.
L'operazione di taglia e cuci tra le varie versioni del film ha così portato ad un prodotto che di certo non fa rimpiangere la bruttezza di The Marvels, ma che alla fine è di una blandezza sconcertante: poco meno di due ore dove nulla risalta, la storia è basilare e priva di veri spunti di interesse e l'azione, pur ben congegnata, è piatta.
La cosa più evidente è come tutta la trama manchi di un focus preciso. Tutto dovrebbe essere trainato dalla vendetta del Leader, che finalmente si mostra a quasi vent'anni dal cliffhanger visto ne L'Incredibile Hulk. Una vendetta volta a mostrare al mondo come il suo carceriere Thunderbolt Ross non sia cambiato, sia ancora il "caccia-Hulk" guerrafondaio delle origini e non un presidente preoccupato per il bene dell'intero globo. Una motivazione in realtà evanescente, che riduce ad un semplice scontro di personalità una storia che avrebbe anche ambizioni da fantapolitica e spy-story.
L'eco di The Winter Soldier è forte nella prima parte, dove il mistero sugli agenti dormienti è il traino principale, così come la tematica della collaborazione mondiale per il corretto sfruttamento delle risorse, qui il mitico adamantio, riletto come il materiale di cui è costituito il celestiale nato alla fine di Eternals e ora calcificatosi.
Ma più il film procede, più questa ambizione si va perdendo e il tutto alla fine si appiattisce sulle più che ovvie coordinate di un thriller d'azione. Fino ad arrivare al mid-point, con il disvelamento del villain e la scelta di virare tutto verso l'action scontato.
La cosa strana che emerge da questo montaggio definitivo è come Sam Wilson non abbia nessun peso narrativo. Il vero protagonista è Thunderbolt: suo è il conflitto, suo l'arco caratteriale. E va dato merito a Harrison Ford, ultraottantenne e a sua detta a che fare con un personaggio nel quale si è limitato a fare lo scemo, il quale non si è risparmiato e ha dato comunque una buona performance. Anthony Mackie, d'altro canto, appare talvolta spaesato, probabilmente a causa delle molteplici sessioni di riprese; ma il problema è proprio il personaggio per se stesso, il quale è il classico "eroe che non si sente all'altezza del mentore", praticamente lo Spider-Man di Homecoming, qui riproposto giusto per dare un senso al fatto che sia lui il protagonista; un conflitto che per di più sembrava aver superato alla fine della serie in streaming e che qui ritorna solo perché altrimenti non avrebbe letteralmente nulla da dire. E quando poi questo Cap senza poteri si rialza come se niente fosse dopo aver subito colpi di accetta e d'arma da fuoco, la sospensione dell'incredulità vacilla.
Quanto agli altri personaggi, c'è davvero poco da dire. Il nuovo Falcon, vero e proprio Robin della situazione, è una macchietta. Ruth Seraph è lì giusto per fare numero e la scelta di far interpretare un ex vedova nera e agente di sicurezza supercazzuta a Shira Haas, attrice di un metro e mezzo, genera matte risate. Quanto al Leader è un mcguffin vivente e nulla più, tutte le potenzialità derivanti da un cattivo il cui potere è praticamente quello di predire il futuro vengono evitate per risparmiarsi mal di testa in sede di scrittura (o riscrittura o ri-riscrittura, chissà).
Juluis Onah ha anche diretto The Cloverfield Paradox, ma il suo curriculum è quello di un autore indie; la scelta di affidargli la regia di un blockbuster, inutile cercare di negarlo, è ascrivibile al suo essere afroamericano (evidentemente solo un nero può dirigere un film su di un Cap nero...). La sua volontà di creare scene divertenti è forte, ma paga lo scotto dell'inesperienza: le coreografie sono convincenti, ma la costruzione delle singole scene è ovvia e priva di inventiva. L'unico momento in cui riesce a dare qualcosa di apprezzabile è ovviamente nello scontro finale contro Hulk Rosso, il quale però dura troppo poco per giustificare la visione.
La noia, come da copione, fa capolino, visto la basilarità della storia e la debolezza della messa in scena. Alla fine, più che ad un blockbuster da sala, sembra di stare guardando un semplice special direct-to-streaming: un qualcosa di dignitoso, ma totalmente dimenticabile.